Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
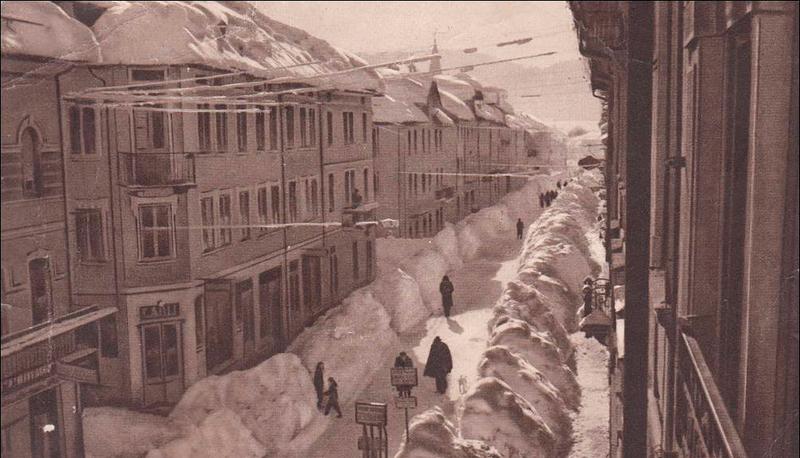
L'ottocento: un secolo di passaggio tra innovazioni reali e illusorie
“Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Quando io vi offendo in qualunque
modo e con qual sia mezzo, io non me n’avveggo se non rarissime volte: come, ordinariamente, se
io vi diletto e vi benefico, io non lo so…”. La Natura sempre e dovunque indifferente se non ostile
ad ognuno dei suoi figli, è incapace di procurar loro quella felicità che è il fine di ogni essere
vivente e che sarebbe lo sbocco più naturale di un reale progresso umano.
Per quanto riguarda il “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, esso è il canto che meglio
esprime il pessimismo cosmico di Leopardi: in ogni tempo e in ogni luogo, ciò che caratterizza
l’esistenza è il dolore e l’infelicità. In quest’opera il poeta non parla in prima persona ma fa parlare
il pastore nomade dell’Asia che di fronte alla luna, che lo segue in tutti i suoi spostamenti, si pone
degli interrogativi sul senso dell’esistenza e sulla posizione dell’uomo all’ interno dell’universo. Le
domande del pastore rimangono, però, senza risposta. Dall’osservazione della realtà che lo circonda
(il gregge), il pastore arriva a concludere che il destino di ogni creatura, uomo o animale, è il
dolore; egli in questo canto rappresenta l’uomo di fronte al mistero esistenziale dell’intero
universo, rappresenta l’uomo sperduto e incapace di spiegarsi la ragione dell’esistenza delle cose e
del proprio destino.
Tale critica dell’idea di progresso e della concezione positiva della natura è una novità nel
panorama storico letterario: i letterati che, nel Settecento credevano in un’epoca di progresso
inarrestabile, esercitano nell’Ottocento italiano una funzione critica che si svilupperà ulteriormente
nel Novecento. 6
L’Unità d’Italia
Il Congresso di Vienna fu convocato il 22 settembre del 1814 dalle potenze (Austria, Gran
Bretagna, Prussia e Russia) che sconfissero Napoleone Bonaparte con l’obiettivo di ripristinare
l’assetto politico europeo presente prima delle campagne napoleoniche. A questo congresso
parteciparono ben 216 delegazioni provenienti da tutta Europa, tra le quali anche la Francia con il
ministro Talleyrand in veste di osservatore. Dominatore indiscusso del congresso fu il primo
ministro asburgico Metternich. Il congresso si prefiggeva anche l’obiettivo di dare all’Europa un
assetto stabile per impedire le mire espansionistiche della Francia. Vi era un solo modo per
garantire la pace duratura in Europa: limitare il potere di ciascuna potenza in modo che nessuna di
esse risultasse troppo rafforzata rispetto alle altre.
Due furono i principi alla base del lavoro del Congresso:
1. Il principio di equilibrio, volto ad impedire che uno Stato potesse imporsi sugli altri;
2. Il principio di legittimità con il quale si restaurarono sui troni le dinastie regnanti prima delle
campagne napoleoniche.
La tendenza del Congresso fu quella di rafforzare l’assolutismo monarchico e di impedire la
diffusione delle idee francesi. Lo spirito della restaurazione fu perciò antiliberale e volto alla
negazione del principio di nazionalità (popolo sovrano).
Dopo aver riorganizzato l’assetto politico europeo bisognava preservarlo il più a lungo possibile.
Nel settembre 1815, su iniziativa dello zar Alessandro I, Russia. Prussia ed Austria firmarono il
documento istitutivo della Santa Alleanza, patto questo che non vincolava i contraenti ad alcun
obbligo preciso e concreto. Il testo affermava che i sovrani si sarebbero prestato aiuto e soccorso in
ogni luogo e in ogni occasione. In un secondo tempo aderirono alla Santa Alleanza anche altre
potenze europee, tra le quali la Francia. Nel novembre del 1815, su iniziativa britannica, fu stipulata
la Quadruplice Alleanza tra Gran Bretagna, Russia, Prussia ed Austria, volta ad impedire che
l’assetto e l’ordine delineati dal Congresso potessero essere rotti. La Francia venne posta a
sorveglianza speciale da parte dell’Alleanza e inizialmente rimase esclusa dal “concerto europeo”.
Nel 1818 il Congresso di Aquisgrana riconobbe la Francia come una potenza e le concesse di far
parte del concerto. Nacque così la Pentarchia.
La risposta alla politica antiliberale del Congresso non si fece attendere I gruppi liberali, che
chiedevano l’instaurazione di governi costituzionali, erano una minoranza politica e sociale che
faceva capo principalmente ad esponenti intellettuali e della borghesia imprenditoriale. Questi
gruppi non potendo operare alla luce del sole si organizzarono in società segrete con attività
cospirativa clandestina. In Italia la società segreta più famosa era la Carboneria che aveva filiali in
tutta la penisola.
Negli anni 1820-1821, in Spagna, in Portogallo e in Italia scoppiarono dei moti insurrezionali
promossi da gruppi liberali i quali, però, non ottennero l’appoggio delle masse popolari. Nella
penisola iberica questi moti costrinsero i regnanti a promulgare delle Costituzioni. In Italia il 1
luglio 1820 scoppiarono dei moti insurrezionali che interessarono il Regno delle Due Sicilie. I moti
furono promossi da Michele Morelli e Giuseppe Silvati, due ufficiali carbonari, e ben presto
dilagarono in tutto il napoletano. Alla rivolta si unì anche Guglielmo Pepe, ex ufficiale napoleonico,
assumendone il comando. Il re Ferdinando I fu costretto a concedere la Costituzione. Il 15 luglio
1820 la rivolta esplose anche in Sicilia dove il moto assunse, oltre al carattere costituzionale,
soprattutto quello separatista. Il governo di Napoli inviò Florestano Pepe il quale, per reprimere il
moto, cercò di trattare con i rivoltosi, ma invano. Fu inviato quindi Pietro Colletta il quale sedò la
rivolta nel sangue (settembre 1820). Animati dagli eventi accaduti in Spagna e nell’Italia
meridionale, le società segrete lombarde e quelle del regno di Sardegna intensificarono la propria
attività cospirativa, ma nell’ottobre del 1820 la polizia austriaca arrestò alcuni carbonari tra i quali
7
Pietro Maroncelli e Silvio Pellico. Federico Confalonieri, capo della setta segreta dei federati di
Lombardia, decise di passare all’azione pensando di poter contare sull’appoggio di Carlo Alberto,
principe di Carignano, il quale nutriva simpatie per i gruppi liberali. Il moto piemontese fu guidato
dal conte Santorre di Santarosa. In Piemonte la guarnigione militare dei rivoltosi raggiunse Torino il
12 marzo. Vittorio Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice il quale, trovandosi a Modena,
affidò la reggenza a Carlo Alberto. Questi concesse la Costituzione che sarebbe entrata in vigore a
seguito dell’approvazione di Carlo Felice. Il re sconfessò l’iniziativa di Carlo Alberto e minacciò di
unirsi alle truppe di Novara, fedeli alla Corona. In Lombardia, invece, i piani di Confalonieri furono
scoperti dalla polizia austriaca e l’insurrezione saltò. In aprile Carlo Alberto al capo di un esercito
piemontese e austriaco sconfisse i rivoltosi di Santorre di Santarosa a Novara; così si concludero i
moti rivoluzionari del 1820-21.
L’Austria che era la più interessata, a reprimere i moti fece convocare a Troppau un congresso
dove Austria, Russia e Prussia proclamarono il principio d’intervento. In un Congresso a Lubiana
fu deciso l’intervento armato nel napoletano. Il 23 marzo 1821 le truppe austriache abbatterono il
regime costituzionale napoletano.
Con il Congresso di Verona fu dato mandato alla Francia di reprimere il regime costituzionale
spagnolo che, nonostante l’accanita resistenza dei gruppi liberali, cadde nell’ottobre del 1823. In
Portogallo, invece, il regime costituzionale fu soppresso dalle forze assolutiste interne,
riorganizzatesi nel frattempo.
Nel 1830 scoppiarono in Europa nuove rivolte che determinarono in Francia e in Belgio una prima
rottura negli assetti stabiliti dal Congresso di Vienna. In Francia scoppiò una rivolta popolare contro
Carlo X il quale era intenzionato a ripristinare totalmente l’antico regime. La “rivoluzione di luglio”
portò sul trono francese il conte Luigi Filippo d’Orleans. La Francia divenne così una monarchia
costituzionale. In Belgio il 23 agosto 1830 a Bruxelles la popolazione insorse chiedendo
l’indipendenza dall’Olanda. L’intervento dell’Alleanza a difesa del re Guglielmo I fu impedito da
Luigi Filippo d’Orleans il quale affermò che per garantire la pace in Europa era necessario non
intervenire. Il Belgio divenne così uno Stato indipendente e poté dotarsi di una Costituzione
liberale. In Italia l’attività cospirativa della carboneria non si era arrestata, ma era rimasta vitale
soprattutto nell’Italia centrale.
Gli eventi parigini spronarono i gruppi liberali all’azione. La carboneria, grazie ad Enrico Misley
aveva preso contatti con Francesco IV duca di Modena il quale era intenzionato a costruire uno
Stato nell’Italia centro-settentrionale sfruttando i moti liberali. Nella rivolta diretta da Ciro Menotti
furono coinvolte l’Emilia, la Romagna e le Marche. L’improvviso cambiamento dell’atteggiamento
di Francesco IV portò, però, all’arresto di Ciro Menotti ma non impedì lo scoppio della rivolta.
Grazie a questi moti, nei ducati di Parma e Toscana e in alcuni territori pontifici furono instaurati
dei governi provvisori; l’esercito dei rivoluzionari, però, non riuscì a resistere alla reazione
austriaca. Nell’Italia centrale furono così ristabiliti i sovrani preesistenti. Le cause principali
dell’insuccesso di questi moti furono il mancato appoggio sia delle masse popolari che di una
grande potenza.
L’insuccesso dei moti carbonari fu dovuto da una parte al metodo di lotta e dall’altra al mancato
appoggio popolare . Uno dei protagonisti del movimento nazionale italiano fu Giuseppe Mazzini,
membro della carboneria, il quale puntava alla costituzione di un’Italia “una, libera, indipendente e
repubblicana”.
Mazzini rifiutava l’idea di un’Italia federale; era convinto che uno Stato centralizzato avrebbe
meglio rappresentato l’unità nazionale. Secondo Mazzini il popolo aveva come missione quella di
portare a termine l’unità nazionale che non doveva essere realizzata da un sovrano italiano né con
l’aiuto di una potenza straniera ma attraverso un’insurrezione popolare. 8
Nel 1831 Mazzini fondò la Giovine Italia, un’organizzazione clandestina nazionale che doveva
incitare alla lotta popolare. La visione mazziniana, però, andava di là dei confini nazionali: da ciò la
nascita della Giovine Europa che fu fondata dallo stesso Mazzini nel 1838.
Il metodo scelto da Mazzini per la lotta fu quello del ricorso ai moti insurrezionali che avrebbero
innescato poi una sollevazione delle masse popolari preparate all’azione per mezzo della
propaganda. I tentativi insurrezionali promossi dai mazziniani si trasformarono tutti in pesanti
sconfitte. I motivi di tali insuccessi vanno principalmente ricercati nella propaganda di obiettivi che
le masse popolari non recepivano come propri e nell’incapacità di “convincere” le masse.
Gli obiettivi indicati da Mazzini non coinvolgevano la stragrande maggioranza della popolazione
costituita da contadini (Mazzini, ad esempio, non affrontava il problema della terra per loro
fondamentale).
Tra i tentativi insurrezionali falliti vi è quello dei fratelli Bandiera che, non avendo ottenuto
l’appoggio dei contadini calabresi, furono catturati e fucilati dai Borboni.
In Italia, mentre i mazziniani “perdevano colpi” anche a causa del fallimento dei moti
insurrezionali, si andavano affermando, guadagnando consensi, i liberali moderati la cui visione
prevedeva un processo d’unificazione lento e senza spargimento di sangue: tale processo si sarebbe
concluso con la nascita di uno Stato federale.
Nel 1848 l’Europa fu nuovamente investita da un’ondata di moti insurrezionali. In Francia la
situazione politica ed economica era estremamente precaria a causa dell’atteggiamento di stampo
conservatore assunto da Luigi Filippo d’Orleans. Gli oppositori del sovrano diedero vita alla








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









