vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
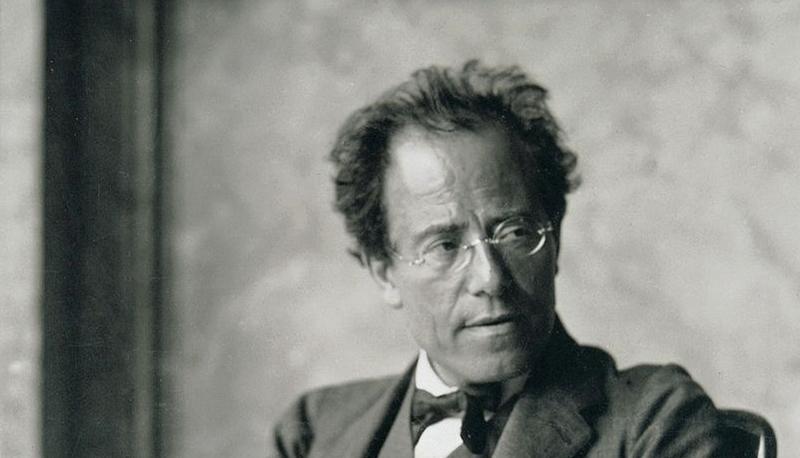
1
Ilaria Collini
Classe 5° sez. A
Liceo Scientifico A.M.E. Agnoletti
Anno scolastico 2007\08 2
Mappa concettuale:
I primi anni del
900 in un
periodo di crisi:
con le sue
inquietudini ed
illusioni Storia:
Italiano: Inglese:
La Prima
Filosofia:
Pirandello James Joyce
guerra
Schopenhauer mondiale 3
Introduzione:
La cultura dell'Ottocento è saldamente ancorata a una concezione forte dell'io, inteso
come sostanza razionale e unitaria. Già nel corso dell'Ottocento, tuttavia, non erano
mancate autorevoli voci controcorrente, precorritrici della successiva evoluzione
culturale, che rimasero non a caso isolate, incomprese e a volte perfino sconosciute fino
all'ultimo trentennio del secolo. Una di queste è Schopenhauer, che con il libro “Il mondo
come volontà, e rappresentazione” (1818) riduce il soggetto umano a semplice
manifestazione di un principio metafisico, impersonale e del tutto irrazionale: la volontà
di vita.
Con l’avvento del nuovo secolo si ha l’esplosione della crisi. La prima meta del Novecento
è segnata da due catastrofiche guerre mondiali, dalla Rivoluzione russa dalla prima
grande crisi economica di livello mondiale, da conflitti sociali violenti che spesso
sfociarono in tentativi insurrezionali falliti o repressi, da genocidi tecnologicamente
pianificati, da regimi dittatoriali e totalitari. In questo contesto storico il mito
ottocentesco di un io razionale capace di esercitare un controllo sugli istinti attraverso la
morale e la politica, e sulle forze della natura grazie alla scienza e alla tecnica, si
frantumò definitivamente. Nel primo Novecento il tema della crisi dell'io è il motivo
fondamentale dei grandi romanzi europei: nell’Ulisse (1922) di James Joyce , l'eroe del
romanzo ottocentesco si trasforma in antieroe, l'inetto, l'escluso, l'uomo senza qualità, e,
parallelamente, viene attuata una rivoluzione nella forma romanzesca: il narratore
onnisciente viene sostituito dallo stream of consciousness (lett. "flusso di coscienza"),
dalla mera registrazione dei mutevoli stati dell'io, che disarticola in tal modo la continuità
spazio-temporale della narrazione. L’autore italiano che, almeno sul piano del contenuto,
ha forse espresso con più radicalità la dissoluzione dell'io - e con largo anticipo sugli altri
- è Luigi Pirandello. I personaggi di Pirandello sono uomini disgregati, dalla personalità
alterata, maniacale, emblemi del caos dell'esistenza. Essi scoprono l’inconsistenza del
proprio io che diviene un flusso di percezioni mutevoli, un susseguirsi di frammenti in
perenne mutamento, il frutto delle innumerevoli proiezioni del suo ambiente sociale. In
altre parole, il soggetto si frantuma in una miriade di frammenti attraverso i quali
sembra impossibile poter ricostruire una realtà. 4
Luigi Pirandello (1867 – 1936)
Il senso di inquietudine e di smarrimento, di incertezza che caratterizza la letteratura
italiana del Primo Novecento, trova la sua espressione artistica , nella vasta produzione
narrativa e drammatica di Luigi Pirandello, nato ad Agrigento nel 1867 compì gli studi
prima a Roma poi a Bonn dove si laureò con una tesi in linguistica. Dopo il tracollo del
patrimonio paterno insegnò a Roma presso l’istituto magistrale. La vita familiare fu
segnata dal dolore per le condizioni mentali della moglie. Il successo gli arrivò improvviso
5
e clamoroso intorno al 1920 e si consolidò fino a procurarsi una fama mondiale che
culminò con il conferimento del premio Nobel per la letteratura nel 1934. Morì a Roma
nel 1936.
L’opera pirandelliana mira a rappresentare la complessità del dramma umano nel suo
ritmo biologico ed esistenziale come si evince dalle numerose Novelle (confluite nella
raccolta “Novelle per un anno”) e da “L’esclusa”. Quest’ ultima segna, in modo
particolare, il distacco dello scrittore dal Verismo alla cui oggettività sostituisce una
visione personale della vita, in quanto ritiene che nulla esiste, di vero e di oggettivo al di
fuori dell’animo umano. “L’esclusa”
Marta Ajala, protagonista del primo romanzo , è una donna che viene
cacciata di casa perché ritenuta adultera e poi riammessa in famiglia quando
effettivamente, per varie circostanze, commette adulterio. E proprio in questo romanzo si
rivelano i temi di fondo di tutta la produzione pirandelliana:
1) contrasto tra apparenza e realtà;
2) lo sfaccettarsi della verità in tante verità quanti sono coloro che presumono di
possederla;
3) l’assurdità della condizione dell’uomo e della sua catalogazione (adultero, innocente,
ladro, jettatore (il personaggio della “Patente”)), in una forma cristallizzata che soffoca la
vita. Di questa assurdità che deriva sia dal caso che regna nelle vicende umane, sia dalle
convenzioni sociali, che sono il prodotto della storia, Mattia Pascal è un esemplare
testimone.
Il fu Mattia Pascal racconta la strana vicenda di un uomo Mattia Pascal, che
allontanatosi da casa per liberarsi da un matrimonio fallimentare e dalla vita asfissiante
di un piccolo centro provinciale, apprende per caso dal giornale la notizia della propria
morte. La moglie l’ha riconosciuto nel cadavere di un annegato trovato nelle acque di un
canale. Mattia Pascal si ritrova così inaspettatamente liberato dalla “forma” in cui la vita
lo aveva cristallizzato e decide di costruirsi un’ esistenza diversa e migliore. Ma dovrà ben
presto accorgersi che la società non gli concede questa libertà. A Roma, dove si stabilirà
sotto il nome di Adriano Meis gli ingranaggi sociali lo riprendono, si rende conto di non
poter vivere senza un’ identità anagrafica , non può affittare una casa, non può sposare
la donna che ama, perciò si rassegna a tornare al paese col proposito di rientrare nella
sua “parte” originaria. Ma neanche questo gli è ormai concesso, la moglie si è ormai
risposata e ha avuto un figlio e per tutti egli è ormai un estraneo. Dopo un momento
iniziale di rabbia egli rinuncerà a presentare un’ azione legale, rinuncerà ad esistere,
accetterà di restare per tutti il “fu Mattia Pascal”.
Il brano “ Lo strappo nel cielo di carta” tratto dal capitolo XII del “Fu Mattia Pascal”
evidenzia motivi e temi che poi saranno propri delle successive opere dello scrittore.
Il protagonista, nella nuova identità di Adriano Meis, a Roma vive in una pensione presso
la famiglia di Anselmo Paleari , un funzionario del ministero della Pubblica istruzione
mandato in pensione per le sue stranezze, che ama intrattenere il suo ospite enunciando
bizzarre teorie filosofiche.
- La tragedia d'Oreste in un teatrino di marionette! - venne ad annunziarmi il signor
“
Anselmo Paleari. - Marionette automatiche, di nuova invenzione. Stasera, alle ore otto e
mezzo, in via dei Prefetti, numero cinquantaquattro. Sarebbe da andarci, signor Meis.
- La tragedia d'Oreste?
D'après Sophocle,
- Già! dice il manifestino. Sarà l'Elettra. Ora senta un pò, che
bizzarria mi viene in mente! Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta
che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si
facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei.
- Non saprei, - risposi, stringendomi nelle spalle.
- Ma è facilissimo, signor Meis! Oreste rimarrebbe terribilmente sconcertato da quel 6
buco nel cielo.
- E perché?
- Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gl'impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli
con smaniosa passione , ma gli occhi , sul punto, gli andrebbero lì a quello strappo,
donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cader le
braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la
tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure: in un buco nel cielo di carta.
E se ne andò, ciabattando.
Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni il signor Anselmo lasciava spesso precipitar
così, come valanghe, i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l'opportunità di essi rimanevano
lassù, tra le nuvole, di modo ché difficilmente a chi lo ascoltava riusciva di capirci
qualche cosa.
L'immagine della marionetta d'Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase
tuttavia un pezzo nella mente. A un certo punto: «Beate le marionette,» sospirai, «su le
cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi! Non perplessità angosciose, né
ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà: nulla! E possono attendere bravamente e prender
gusto alla loro commedia e amare e tener se stesse in considerazione e in pregio, senza
soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è
un tetto proporzionato.”
Il dialogo tra Anselmo Paleari e Mattia-Adriano, inserito quasi di passaggio nel corso del
romanzo , ruota attorno a tre immagini che hanno un evidente significato metaforico:
1) il teatrino di “ marionette automatiche” che richiama la commedia della vita, nel
corso della quale gli esseri umani recitano inconsapevolmente una parte che gli è
stata assegnata dal caso o dal destino.
2) Lo “strappo nel cielo di carta” collegato da Paleari alla differenza fra tragedia
antica e moderna: la metafora allude al fatto che i punti saldi di riferimento
religiosi, ideali, morali che caratterizzavano il mondo antico sono caduti.
3) Per questo l’uomo moderno non può più assomigliare a un eroe come Oreste,
sostenuto da un saldo sistema di certezze nel componimento della sua vendetta,
ma ad Amleto , individuo problematico e contraddittorio, pieno di dubbi,
inquietudini e oscillazioni.
L’assenza di certezze di fronte ad una realtà in continuo mutamento è alla base di
“Uno, nessuno e centomila” il romanzo di scomposizione della vita. Qui tutta la
narrazione mette in luce l’autodistruzione di una personalità consapevole della propria
incapacità di chiudersi in una forma coerente e autentica, della falsità ineluttabile dei
rapporti con altri e con se stessi. La crisi di Vitangelo Moscarda inizia quando sua moglie
gli fa osservare che il suo naso pende verso destra, cosa a cui non aveva mai fatto caso.
“ “Che fai?” mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo
specchio.
“Niente”, le risposi, “mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo,
avverto un certo dolorino.”
Mia moglie sorrise e disse:
“Credevo ti guardassi da che parte ti pende.”
Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda:
“Mi pende? A me? Il naso?”
E mia moglie, placidamente:
“Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra.” ”
La prima reazione del protagonista è il “proposito disperato” di conoscere quell’ estraneo
che è in lui, credendo in maniera sbagliata che esso sia solo uno per tutti. Il dramma si 7
complica quando scopre di essere centomila non solo per gli altri, ma anche per se
stesso. Inizia così per lui la crisi della sua personalità e del principio d’identità. Egli cerca
di distruggere le false immagini di sé che sono negli altri e in lui stesso, ma non potrà
farlo se non estraniandosi dal contesto sociale. Moscarda alla fine rinuncia all’ambizione
di darsi una forma per lasciare che la vita viva in lui, senza la volontà di costruirsi, senza
più sentimenti e memoria. Solo ora è felice, avendo rinunciato ad ogni pretesa d’identità,
non riconoscendosi più nel proprio nome e vivendo completamente fuori di sé, vagabondo
nel flusso della vita universale come un albero, una nuvola, il vento. E solo così egli si
salva.
Da tutto ciò si evince che l’uomo è sempre un vinto, la cosiddetta personalità è un puro
sogno, perché l’Io, costretto ad entrare in continuo rapporto con il mondo esteriore, non
può mai definirsi, nella sua completezza, ma solo relativamente al singolo rapporto.
L’uomo è uno, nel momento del singolo rapporto; è nessuno, quando si distruggerà per
determinarsi in un altro rapporto; è centomila per questo suo farsi continuo; e se manca
il rapporto con l’altro, l’uomo continua a costruirsi lo stesso, alimentando le illusioni,
perché bisognoso di illudersi, per non vedersi quale esso è.








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









