Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
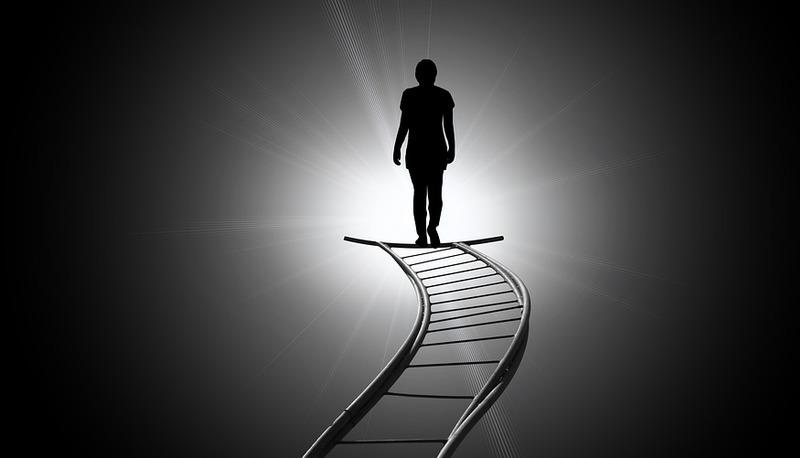
"Non riceviamo una vita breve,ma tale la rendiamo:e non siamo poveri quanto
alla vita,ma la sprechiamo con prodigalità" (De Brevitate Vitae )
Questa frase fu scritta da uno dei più grandi scrittori Latini ,Lucio Anneo Seneca
(4a.C.- 65d.C.). Seneca, nacque all’incirca nel 4 a.C. a Cordova ed essendo
figlio di un retore, fu inviato a Roma per completare gli studi in previsione della
sua carriera politica. A Roma ebbe come maestri di filosofia lo stoico Attalo ed il
neopitagorico Sozione, mentre il retore Papirio Fabiano lo mise a contatto con la
scuola filosofica dei Sestii. Da costoro Seneca derivò un orientamento ascetico
che lo accompagnerà tutta la vita. Seneca, come del resto la maggior parte
degli intellettuali romani che si occuparono di filosofia, fu animato da un
atteggiamento non dogmatico verso le principali scuole di pensiero greco-
ellenistico. Aderì principalmente allo stoicismo, ma nella sua filosofia sono
riconoscibili anche elementi platonici, neopitagorici e cinici. Il nucleo di
pensiero prevalente fu comunque quello stoico: il suo interesse per la natura , il
concetto di divinità, l’insistita riflessione morale, lasciano arguire che Seneca
non fu solo seguace dello stoicismo, ma ne sviluppò anche con originalità
alcune posizioni. Nonostante il saldo ancoraggio alla tradizione filosofica a lui
precedente, si può notare in tutta l’opera di Seneca una continua polemica
contro la filosofia insegnata nelle scuole, sinonimo spesso di un’erudizione fine
a se stessa, contraria al principio che la sapienza non è in verbis, bensì in rebus
. La fondamentale trattazione della tematica del tempo era già stata sviluppata
da Seneca nell’opera De brevitate vitae . Oltre affermare chela vita non è
breve, ma siamo noi a renderla tale, sprecando gran parte del tempo che il
destino ci ha concesso, Seneca espone il proprio concetto di tempo, integrando
la prospettiva degli stoici con quella degli epicurei: il saggio non deve affidare
nulla della propria vita al futuro, perché la vita può cessare da un momento
4
all’altro; egli deve invece interessarsi solo al presente, vivendo ogni singolo
giorno come se fosse l’ultimo.
VALENZA FORMATIVA E MORALE DELLA MORTE
Ogni uomo, in quanto essere razionale, ha la possibilità di interrogarsi di fronte
al succedersi degli avvenimenti e, dunque, di fronte alla vita. Ma ciò significa
che, se la vita implica la morte, l'uomo ha la possibilità di interrogarsi sulla
morte. Anzi: proprio l'interrogazione relativa al senso della morte diventa uno
dei momenti che caratterizzano l'espressione della vita e, in particolare, della
vita del sapiente Di fronte alla vita, e quindi di fronte alla morte, il sapiente
stoico deve dimostrare la propria virtù: deve cioè confermare la propria
capacità di essere in sintonia con il senso complessivo del divenire. In pratica,
la virtù del sapiente consisterà nel mantenere ferma la propria forza razionale
lasciando che essa si esprima di fronte a qualsiasi evenienza, compresa quella
estrema: appunto la morte.
Ma non è facile mantenersi saldi e avere la forza di resistere incrollabili e saggi
di fronte alla morte e a quanto, come la malattia e il dolore, di essa è
l'annuncio. Anzitutto occorre rendersi conto che “la distanza dalla morte è
ovunque breve: non è che la morte si mostri in ogni luogo vicina: essa è
realmente in ogni luogo vicina”. La morte, in questa prospettiva, rivela la sua
fortissima valenza formativa.
IL “NON ESSERE” NELLA MORTE
Seneca farà presente all'amico Lucilio, che proprio il modo in cui moriamo dirà
chi davvero siamo; suggerirà quindi che il miglior rimedio per vincere la morte
è semplicemente quello di disprezzarla. Più seriamente, occorrerà considerare
la morte per quello in cui di fatto consiste: 'la morte è non essere', è la pura e
semplice condizione in cui vi è l'assenza della percezione della vita, l'occasione
in cui il venir meno del corpo si accompagna al venir meno della percezione e
quindi della coscienza; così si ricava dalla tragedia Le Troiane, vv. 401-02: “la
morte è qualcosa di indivisibile: un malanno del corpo che non risparmia lo
spirito”. Essa finisce per essere un punto d'arrivo ineffabile: si badi, non solo
dopo la morte non c'è nulla, ma il morire medesimo è qualcosa di sfuggente, è
il limite estremo di un rapidissimo spazio di tempo.
Works: he wrote "Elegy Written in a Country Churchyard". Gray took more
than seven years to write this elegy, which was probably inspired by the
death of his friend West. This poem can be divided into three moments.
Stanzas 1 - 11: in a small country churchyard in Stoke Poges, at the end
of the day, the sight of the tombs of the "rude forefathers of the hamlet"
calls up in the poet's mind images of humble country life. These images,
rich in symboilc elements, such as the elmets, the yews, the cockcrow, the
horn and the sickle, lead Gray to meditate on death and on its levelling
power. Stanzas 12 - 21: Gray compares the humble lot of poor people
with the great careers from which their fate excluded them. But he also 5
considers how their poverty also prevented them from committing crimes
and falling victims of luxury, pride and corruption.
Stanzas 22 - 32: the poem ends with the supposed death of the author,
his burial in the same churchyard and the epitaph on his tomb.
Comment: the neoclassical idealization of poor country life conceals the
denunciation of what poverty means in term of hardship and unfulfilment
so that the "rude forefathers" come to be seen in the double role of both
happy people and victims of nature and society. Their tombs silent and
obscure, become therefore the natural conclusion of an equally silent and
obscure life, simbolized, among the other things, by the "buried gem" and
the "unseen flower".
Style: the poem is base on an alteration of description and reflections.
This tecnique was dear to neoclassic poets, as it enabled them to break
the possible monotony deriving from using one only of these two types.
The sepolcal poetry became very popular in Italy, where it inspired,
aming other works, Foscolo's Sepolcri. But Foscolo, concentrated on the
function of the grave as a link between the living and the dead. Foscolo in
fact believed in life continuing after death through the memories of the
living. 6
Lo scrittore italiano Niccolò Foscolo(Ugo fu un nome assunto più tardi dal
poeta) nato a Zante nel 1778 ha una visione della morte simile a quella di
Seneca. Il Foscolo nel romanzo epistolare le "Ultime lettere a Iacopo Ortis
",storia di un giovane patriota che visto svanire tutti i propri sogni, spinto dalla
disperazione amorosa e politica , vede nella morte l' unica via d' uscita da
questa situazione negativa , al tempo stesso insostenibile e immodificabile . La
morte intesa in temimi materialistici e nichilistici , come distruzione totale e <<
nulla eterno>>. Anche nel sonetto "Alla sera" è centrale il concetto del <<
nulla eterno >> , la sera in quanto immagine della morte , è cara al poeta : la
morte ha un'efficacia liberatoria , perché rappresenta l'annullamento totale , in
cui si cancellano conflitti e sofferenze . Nel sonetto "In morte del fratello
Giovanni ", la visione della morte del Foscolo muta , è centrale nel sonetto il
motivo della tomba , che si identifica con l'immagine del nucleo familiare e
soprattutto della madre : sulla tomba il poeta spera di poter ricongiungere il
legame affettivo col fratello e con la madre che parla, con la cenere del figlio
morto , del figlio lontano. Quindi vede la morte come l' unico mezzo per
riaffermare , quel ricongiungimento col nucleo familiare che sembrava
impossibile e definitivamente negato .In questo sonetto la morte non è più <<
nulla eterno >>, ma , essendo << lacrimata >> consente un legame con la
vita. I Sepolcri sono un poemetto scritto sotto forma di epistola poetica di 295
endecasillabi sciolti,indirizzata all 'amico Pindemonte ,originato dall' editto
napoleonico di Saint-Cloud(1804) con cui si imponevano le sepolture fuori dai
confini delle città e si regolamentavano le iscrizioni sulle lapidi. Pindemonte da
un punto di vista cristiano , sosteneva il valore della sepoltura individuale ,
mentre Foscolo da un punto di vista materialistico aveva negato l'importanza
delle tombe , poiché la morte produce la fatale dissoluzione dell' essere .
Foscolo poi ,riprese quella discussione, ribadendo , inizialmente la tesi
materialistica sulla morte , ma superandola , poi con altre considerazioni che
7
rivalutano il significato delle tombe . Quindi anche nei Sepolcri è centrale il
motivo della morte : ma è superata l'idea , che essa sia semplicemente il <<
nulla eterno >>.Anche se Foscolo, sul piano filosofico , non vede alternative a
quella idea , le contrappone l'illusione di una sopravvivenza dopo la morte .
Questa sopravvivenza è garantita dalla tomba che conserva il ricordo del
defunto presso i vivi . La tomba assume per Foscolo un valore fondamentale
nella civiltà umana : è il centro degli affetti familiari e la garanzia della loro
durata dopo la morte . L'Ortis si chiudeva con il suicidio del protagonista , che
escludeva ogni possibilità d' intervento in una situazione bloccata. Ora invece,
attraverso l'illusione , Foscolo arriva a riproporre quella possibilità dell'azione
politica nella storia che l'analisi razionale del contesto portava ad escludere ,
ed introduce la prospettiva di riscatto dell'Italia dalla miseria presente proprio
grazie alla funzione esercitata da un passato di grandezza , tenuto vivo dal
culto delle tombe .Data la presenza di queste tematiche , i Sepolcri, pur avendo
alle spalle il genere della poesia Cimiteriale , che aveva goduto di vasta fortuna
sul finire del Settecento non possono essere ridotti in tale ambito , a differenza
della poesia sepolcrale inglese di Gray è essenzialmente poesia civile e vuole
<< animare l'emulazione politica degli Italiani >>. Ed è centrale nel poemetto
l'idea secondo cui le tombe dei Grandi spingono il << forte animo >> a grandi
imprese ,è l'avvio all'inno di Firenze e alle tombe di S. Croce . Quattro figure di
poeti risaltano nel carme .Il primo è Parini ,poeta civile per eccellenza, che
critica i costumi della società (vv.57-61).Il secondo è Foscolo stesso , che si
ripresenta come eroe perseguitato da una sorte avversa, sconfitto nello scontro
col suo tempo , che aspira ad un << riposato albergo >> nella morte (vv.145-
150).Il terzo è Alfieri,anch' egli ritratto come un'anima grande e tormentata ,in
aspro conflitto con i suoi tempi. L' ultima figura è quella di Omero, in cui si
compendia l'essenza del messaggio dei Sepolcri .Omero incarna
esemplarmente l'immagine sacrale del Poeta . E' il poeta in cui si raccoglie
tutta la tradizione di un popolo , che può così sopravvivere all'azione distruttiva
del tempo. Egli consacra la memoria delle azioni gloriose del passato ,
incitando all' emulazione , ma canta anche gli sconfitti e le loro sventure.
Il poemetto può essere suddiviso in altrettante parti:
― Il testo è suddivisibili in quattro parti, secondo il suggerimento offerto dallo
stesso autore. La prima parte ( vv 1- 90) affronta il tema dell'utilità delle tombe
e dei riti funerari. Da un punto di vista materialistico e laico, essi sono inutili, e
certamente non riscattano per chi muore la perdita della vita. Ma hanno un
senso legato alla dimensione sociale dell'uomo, alla sopravvivenza dell'estinto
nella memoria dei vivi.
― La seconda parte ( vv 91 - 150) è dedicata ad una ricognizione delle varie
concezioni e dei vari usi che si sono susseguiti, rispetto alla morte, nel corso
della civiltà umana.
― Nella terza parte ( vv 151 - 212) è trattato a fondo il rapporto tra significato
privato e significato pubblico della morte e dei riti collegati. Le tombe dei
grandi uomini comunicano ai virtuosi il loro esempio e li stimolano a
proseguirne l'opera; ne è prova ciò che accadde al poeta stesso visitando Santa
Croce, a Firenze, dove sono sepolti molti dei grandi italiani del passato. 8
― Nella quarta parte (vv 213 - 295) oltre ad essere ribadito il valore morale








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









