
La Shoah non è solo una pagina di Storia da studiare, ma una ferita ancora aperta nella coscienza europea. Al colloquio orale della Maturità 2025, dove ogni candidato dovrà costruire un discorso coerente e trasversale a partire da un materiale proposto dalla commissione, questo tema può rappresentare un punto di partenza denso, universale, ancora tragicamente attuale.
Che si tratti di un brano letterario, di un documento storico, di un’opera d’arte o di una riflessione filosofica, il genocidio degli ebrei – e l’intero orizzonte di violenza che lo ha reso possibile – consente di attivare collegamenti profondi tra le discipline, mettendo in luce cause, conseguenze e rappresentazioni culturali della barbarie.
In questo articolo proviamo allora a offrire spunti concreti e intelligenti per costruire un percorso multidisciplinare che, a partire dalla Shoah, sappia coniugare memoria e consapevolezza. Perché il ricordo non è un dovere astratto, ma una responsabilità critica da esercitare, anche a scuola.
Indice
Shoah collegamenti Maturità: Storia
Dal punto di vista storico, la Shoah si inserisce nel più ampio contesto dei totalitarismi del Novecento. È quindi naturale approfondire l’evoluzione del Nazismo in Germania, interrogandosi su come un intero apparato statale sia riuscito a rendere sistematico lo sterminio di milioni di persone. Allo stesso modo, è utile soffermarsi sull’avvento del Fascismo in Italia e sull’introduzione delle leggi razziali del 1938, che anticipano su scala nazionale la discriminazione e la segregazione.
Un focus altrettanto significativo riguarda la natura storica dell’antisemitismo, presente già nel Medioevo con i pogrom, ma radicalizzato e reso “scientifico” nel Novecento attraverso le teorie pseudobiologiche della razza. La Shoah non nasce dal nulla: è il punto di arrivo di una lunga catena ideologica e culturale.
Da non trascurare il ruolo degli altri genocidi del secolo, come quello armeno o quello in Ruanda, per riflettere su dinamiche ricorrenti e sulla necessità di costruire una memoria attiva per prevenire derive simili nel futuro.
Shoah collegamenti Maturità: Letteratura
Anche in Letteratura i riferimenti di certo non mancano. Innanzitutto Primo Levi, chimico e scrittore italiano, autore di opere quali “Se questo è un uomo” e “La tregua”, che raccontano delle sue esperienze nei campi di concentramento nazisti.
Altro autore italiano è Giorgio Bassani, noto soprattutto per la sua opera “Il giardino dei Finzi-Contini”, che esplora la vita e la persecuzione degli ebrei durante il periodo fascista.
Ma l’opera più rappresentativa di tutte è sicuramente il “Diario di Anna Frank”, che vede al centro la vita nascosta della giovane durante l’occupazione nazista ad Amsterdam.
E infine una chicca: un racconto brillante, che offre una prospettiva unica e potente proprio sulla persecuzione ai danni degli ebrei, è quello di Art Spiegelman, fumettista statunitense autore di “Maus”, una graphic novel che rappresenta gli ebrei come topi e i nazisti come gatti.
Shoah collegamenti Maturità: Storia dell’arte
Nella Storia dell’arte non mancano certo i riferimenti ai fatti storici attinenti all’antisemitismo. Tra i più emblematici abbiamo l’opera di Marc Chagall, pittore russo naturalizzato francese di origine ebraica. I suoi dipinti, alcuni dei quali ispirati proprio alla persecuzione degli ebrei che ha caratterizzato gli anni della Seconda guerra mondiale. Interessante porre al centro le modalità di rappresentazione: Chagall spesso rinuncia al realismo a favore di una rappresentazione fantastica e ricca di simboli. Tra i suoi quadri sulla tematica: “Solitudine”, “Crocifissione Bianca”, “La Contestazione”.
Shoah collegamenti Maturità: Filosofia
In Filosofia non possono mancare i ponti storici con la visione nazista e quella fascista, considerate appunto attraverso uno sguardo filosofico. Un’autrice che si rivela particolarmente centrata, per quanto riguarda la tematica della persecuzione ebraica, è sicuramente Hannah Arendt. La filosofa ha analizzato la cosiddetta “banalità del male” (soprattutto nell’omonima opera), esaminando la natura della responsabilità individuale e collettiva durante e di fronte un fenomeno come quello dell’Olocausto.



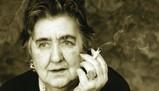



 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo