Concetti Chiave
- La filosofia di Marx critica la borghesia per il suo individualismo e sfruttamento, proponendo una teoria che unisce teoria e prassi, influenzata da Hegel, la sinistra hegeliana e Feuerbach.
- Marx critica Hegel per il suo "misticismo logico", sottolineando la necessità di rendere la filosofia pratica e concreta, pur riprendendo il principio dialettico per analizzare le contraddizioni della società borghese.
- Nei confronti di Feuerbach, Marx evidenzia la mancanza di analisi delle vere cause dell'alienazione, attribuendola al sistema capitalistico e identificando quattro forme di alienazione socioeconomica.
- Il materialismo storico di Marx vede la storia come un processo dialettico di trasformazione dei modi di produzione, con la lotta di classe come motore del cambiamento sociale verso il socialismo e il comunismo.
- "Il Capitale" di Marx analizza la natura del capitalismo, introducendo concetti come plusvalore e criticando la tendenza autodistruttiva del sistema dovuta alla diminuzione del saggio di profitto.
Indice
Critica alla borghesia
La filosofia di Marx è una filosofia critica della borghesia, in quanto classe sociale basata su l'individualismo e, soprattutto, sullo sfruttamento uomo-su-uomo e uomo-su-macchina. Essa è una filosofia che unisce la teoria alla prassi; quindi, assegna una specifica funzione alla teoria (la filosofia). Per questo motivo, per Marx la filosofia non è come la “nottola di Minerva” di Hegel, bensì è paragonabile a una talpa che “scava nel suolo per cambiare il suolo”. La filosofia di Marx vede come punti di riferimento la filosofia di Hegel, la sinistra hegeliana e Feuerbach, dei quali riprende i loro stessi strumenti concettuali e metodologici per criticarli.
Critica a Hegel e Feuerbach
Per quanto riguarda la critica ad Hegel, egli viene accusato di “misticismo. Logico", quindi di mistificare la realtà capovolgendone le premesse, tant'è che Marx dirà che “bisogna far tornare l’hegelismo a camminare con i piedi per terra”. Un celebre esempio di misticismo logico nella filosofia di Hegel si ha nella sua concezione di Stato: Lo Stato, difatti, per Hegel è una manifestazione dello spirito quindi è un momento necessario che precede la condizione di cittadini degli individui, non è creato dalle scelte degli individui, che possono essere sbagliate, e per questo non può essere oggetto di critica (per Marx ovviamente, è tutto il contrario, in quanto lo Stato è stato creato dalle scelte di individui e può quindi essere oggetto di critiche e di discussione nella filosofia politica). Nonostante la critica ad Hegel, Marx però riprende dal filosofo il principio di contraddizione dialettica, applicandolo alla società borghese e alla legge economica che la governa.
Alienazione socioeconomica
A Feuerbach invece Marx critica di non essere andato ad indagare a fondo le cause che portano che portano l'uomo a estraniarsi da sé stesso e, appunto, a rivolgersi a quell’”oppio dei popoli” che è la religione, cadendo inevitabilmente nell'alienazione religiosa; Feuerbach, difatti, ha preferito risolvere la questione sostituendo un'idea (la religione) con un'altra idea, (quella di una natura umana immobile ed eterna. Essa per Marx non esiste, in quanto la natura umana è condizionata dal periodo storico in cui è inserita). Marx invece sostiene che per risolvere l’alienazione religiosa bisogna andare a trovare le radici che portano ad essa: l’alienazione religiosa è sintomo di un’alienazione ben più profonda che sta alla base del sistema capitalistico, ovvero “l'alienazione socio economica”. Essa determina la disumanizzazione dei rapporti lavorativi, e si fonda sulla ricerca del profitto e sullo sfruttamento. L’alienazione socioeconomica si manifesta in quattro modi:
-Estraniazione del lavoratore dal prodotto della sua attività, in quanto produce oggetti che non gli appartengono.
-Estraniazione del lavoratore dalla sua attività, in quanto non si rivede in essa.
-Estraniazione lavoratore della sua essenza, difatti, vendendo la sua forza lavoro, il lavoratore vende la sua caratteristica più umana, ovvero la sua libera e consapevole attività di trasformazione della natura. Questo tipo di estraniazione porta il lavoratore ad essere ridotto allo stato di cosa, e questo influisce anche sul suo rapporto con gli altri.
-Estraniazione del lavoratore dai suoi simili, poiché tutte le sue relazioni sociali sono limitate alla relazione conflittuale con il capitalista, che sta alla base dello sviluppo storico.
Materialismo storico e lotta di classe
il termine “materialismo storico” non è mai stato effettivamente utilizzato da Marx, bensì da Engels nei suoi ultimi scritti. Il termine si riferisce alla concezione marxista nella storia., vista come un processo dialettico mosso da determinate dinamiche socioeconomiche; difatti, per Marx il processo storico coincide con la trasformazione dei modi di produzione, nonché dell'economia che ha caratterizzato un particolare periodo storico. Questi modi di produzione sono la struttura della società (ad esempio, la struttura della società medievale era il feudalesimo) e presentano due elementi fondamentali, ovvero:
- le forze produttive, nonché i componenti coinvolti nel processo di produzione, ad esempio la forza lavoro degli operai o i mezzi di produzione
- i rapporti di produzione, che stabiliscono l'organizzazione del lavoro, ma anche le relazioni tra i soggetti coinvolti nella produzione: stabiliscono quindi chi ha il dominio sui mezzi di produzione, e la classe che li ottiene si afferma come classe egemone (al tempo di Marx, ad esempio, la classe egemone era la borghesia), dalla quale dipende la sovrastruttura della società, ovvero l'insieme delle dottrine etiche, le scoperte filosofiche e scientifiche e la produzione artistica e letteraria, che viene utilizzata dalla classe egemone per legittimare il proprio dominio, presentandolo come necessario e immodificabile. Per Marx quindi la cultura ha una matrice ideologica in misura a quando legittima il dominio della classe egemone.
Socialismo scientifico e fasi del comunismo
Da ciò si evince che ogni struttura economica crea delle classi sociali in conflitto tra di loro. Questo conflitto è definito “lotta di classe” ed è ciò che permette il susseguirsi dei modi di produzione: è grazie alla lotta di classe che la borghesia ha sostituito il feudalesimo, ergendosi a classe egemone e ponendo il presupposto della sua fine, nonché il proletariato. Difatti i proletari, dopo aver preso coscienza nella propria alienazione, si riuniranno per smantellare l'ordine prestabilito, distruggendo quindi il capitalismo e la società borghese. Il socialismo di Marx è definito quindi un socialismo scientifico, perché percepisce l'emancipazione del proletariato come un esito necessario, che “non può non darsi”, e che aprirà agli uomini una nuova fase storica, ovvero quella della società comunista. L’insediamento della società comunista non è però immediato, difatti è da realizzarsi in due fasi.
La prima fase è la fase della dittatura del proletariato, in cui i proprietari si ergono a classe dominante e smantellano ogni residuo del capitalismo (nazionalizzando le banche, abolendo l'eredità, ma anche espropriando tutte le proprietà terriere).
La seconda fase è la fase che prevede l'estinzione effettiva di ogni forma di Stato e l'installazione di una società comunista in cui non vi sono classi sociali.
Critica agli economisti classici
Agli economisti classici, come ad esempio Smith, Marx rimprovera l'aver considerato il capitalismo come unico sistema economico possibile. Per smentire questa idea Marx si immerge nello studio dell'economia politica, e frutto di questi studi è “Il Capitale”, opera considerata ancora oggi il suo capolavoro.
Merce e valore nel capitalismo
L'opera inizia analizzando la merce, termine utilizzato per indicare gli oggetti utili a qualcosa, quindi oggetti che “soddisfano i bisogni umani”. La merce ha un valore d’uso e un valore di scambio.
Il valore d'uso si misura in base all'utilità dell'oggetto.
Per quanto riguarda il valore di scambio, vediamo che tutti gli oggetti possono essere scambiati, per quanto magari diversi tra loro in quantità o in qualità. Questo è possibile poiché tutte le merci hanno un elemento in comune, ovvero la forza lavoro necessaria per produrre ogni merce( difatti la merce è cristallizzazione del lavoro umano)
Ogni merce, nella società odierna, viene scambiata con il denaro, che è essenza stessa del capitalismo, oltre ad essere una merce speciale, perché ha solo valore di scambio e non valore d’uso. Marx descrive il rapporto tra il denaro e la società in due modi:
- Nella società precapitalistica, con la formula M-D-M, quindi merce, denaro, merce. Un esempio di questo si ha in un uomo che vende una padella ed utilizza i soldi che ne ha ricavato per comprare una coperta, quindi un'altra merce.
- Nella società capitalistica Marx descrive questo rapporto con la formula di D-M-D quindi denaro, merce, denaro, in quanto nella città capitalistica il denaro viene utilizzato per ottenere altro denaro e non delle merci. IL modo più corretto per scrivere questa formula è però D-M-D', quindi denaro, merce, più denaro, in quanto il capitalismo consente di guadagnare più denaro rispetto a quello che si è inizialmente investito. Questo è più denaro è definito plusvalore.
Plusvalore e autodistruzione del capitalismo
Il plusvalore è dato dalla forza-lavoro degli operai, nonché l’unica merce che produce nuovo valore. Lo fa perché quando viene impiegata nel processo produttivo, allora produce un valore aggiuntivo a quello che gli viene retribuito nel salario (che corrisponde al valore necessario per il suo sostentamento). Questo valore aggiuntivo è proprio il plusvalore, ed è una parte fondamentale del profitto del capitalista. Vi sono due tipi di plusvalore:
- Plusvalore assoluto, quello che il capitalista ottiene aumentando l’orario di lavoro.
- Plusvalore relativo, quello che il capitalista ottiene riducendo il lavoro necessario per aumentare il plusvalore. Ciò ovviamente comporta la riduzione del salario.
Il capitalismo è inoltre attraversato da una tendenza all’autodistruzione, nonché la “caduta tendenziale del saggio di profitto”, la legge secondo cui il profitto del capitalista tende a diminuire nel tempo, anziché aumentare: difatti, il progresso costringe il capitalista alla meccanizzazione della produzione, spingendolo a impiegare il proprio denaro per l’acquisto di macchine (capitale costante), diminuendo quindi il salario retribuito agli operai (capitale variabile). Il capitale costante però non genera plusvalore, e per questo il profitto del capitalista diminuisce. Inoltre, i lavoratori si impoveriscono e il loro potere d’acquisto viene limitato, quindi la domanda si fa più scarsa e ciò determina una crisi di sovrapproduzione.
Domande da interrogazione
- Qual è la critica principale di Marx alla filosofia di Hegel?
- In che modo Marx critica Feuerbach?
- Cosa intende Marx con "materialismo storico"?
- Qual è la differenza tra il valore d'uso e il valore di scambio secondo Marx?
- Come descrive Marx il rapporto tra denaro e società capitalistica?
Marx critica Hegel per il suo "misticismo logico", accusandolo di mistificare la realtà e di non considerare lo Stato come un prodotto delle scelte individuali, ma come una manifestazione dello spirito.
Marx critica Feuerbach per non aver indagato a fondo le cause dell'alienazione religiosa, limitandosi a sostituire un'idea con un'altra, senza affrontare l'alienazione socioeconomica alla base del sistema capitalistico.
Il "materialismo storico" si riferisce alla concezione marxista della storia come un processo dialettico guidato da dinamiche socioeconomiche, dove i modi di produzione determinano la struttura sociale e la lotta di classe.
Il valore d'uso si basa sull'utilità dell'oggetto, mentre il valore di scambio si riferisce alla capacità di un oggetto di essere scambiato, basato sulla forza lavoro necessaria per produrlo.
Marx descrive il rapporto con la formula D-M-D', dove il denaro viene usato per ottenere più denaro, attraverso il plusvalore generato dalla forza-lavoro, evidenziando la natura del capitalismo di accumulare profitto.

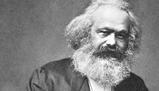





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo