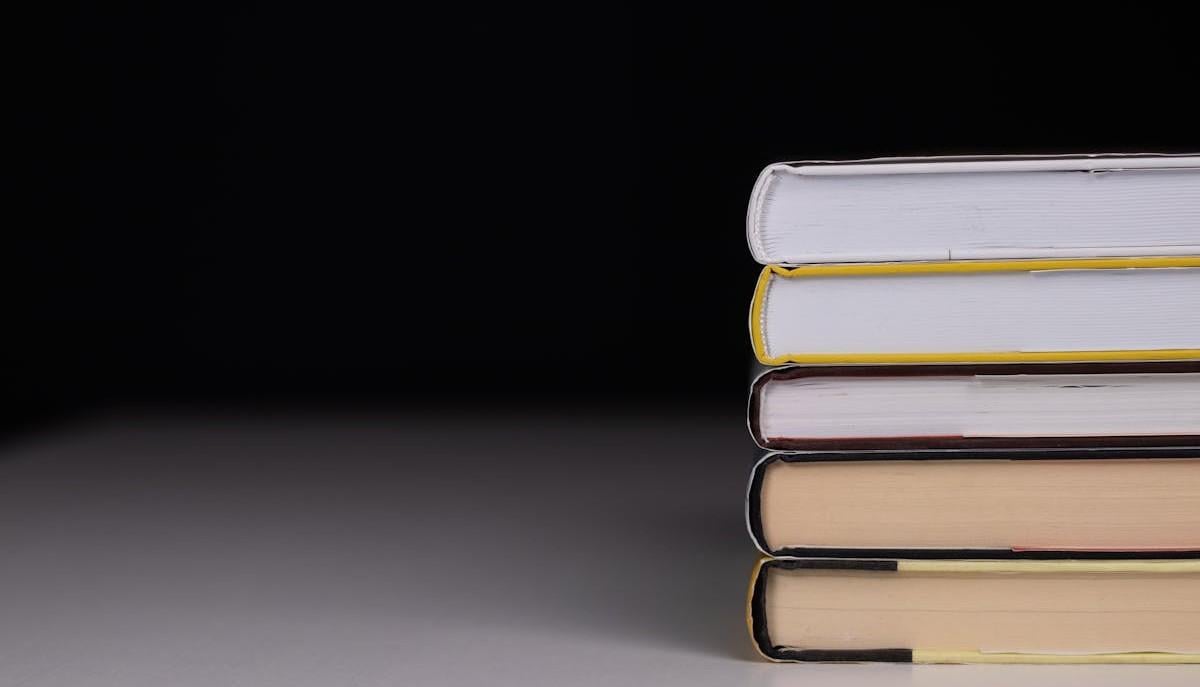
Un mercato da circa 800 milioni di fatturato annui, in mano per lo più a 4 grandi gruppi editoriali, che ne detengono da soli l’80% complessivo. Basterebbero, apparentemente, questi numeri a spiegare perché il valore complessivo delle adozioni dei testi scolastici è aumentato, dal 2019 al 2024, del 2% a fronte di una riduzione della popolazione studentesca del 7%, con il conseguente aumento della spesa attesa per singola unità studente.
Ma, in realtà, il fenomeno - quasi epidemico - del caro libri, che si ripresenta puntuale ogni settembre, è ben più complesso. Come ha evidenziato l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato nella sua indagine conoscitiva sull’editoria scolastica, pubblicata un mese fa dopo un anno di ricerche e audizioni e dalla quale potranno derivare eventuali provvedimenti nei confronti degli operatori di mercato.
Il portale Skuola.net ha letto ed esaminato le conclusioni dell’Antitrust, racchiuse in un corposo documento di oltre 100 pagine, e le ha riassunte in 10 punti semplici e chiari, a disposizione di tutte le famiglie alle prese con questo fenomeno.
Indice
- Non è tanto il caro-libri, ma gli stipendi fermi
- Chi decide, non spende
- Nuove edizioni che passione
- Mercato dell’usato castrato
- Il digitale non fa risparmiare
- Il libro resta sempre di carta (e con tanti fogli)
- Fatta la legge, nessuno (o quasi) la rispetta
- Niente sconti, siamo italiani
- Non toccate il mio libro
- Aiuti di Stato spesi… male
Non è tanto il caro-libri, ma gli stipendi fermi
Tutto sommato, il costo dei libri non è aumentato in maniera spropositata: l’AGCM ha infatti rilevato, tra il 2020 e il 2024, come il prezzo medio dei libri scolastici sia aumentato, rispettivamente, di oltre l’8% alle medie e del 9% alle superiori. Dato in linea con quello dell’inflazione programmata lungo il medesimo periodo.
Il problema è che, nel frattempo, il potere d’acquisto delle famiglie si è deteriorato. E acquistare i libri scolastici resta purtroppo una scelta obbligata.
Chi decide, non spende
Un altro dei motivi per cui la spesa media per studente è comunque aumentata risiede in una anomalia di mercato, per cui chi sceglie quali beni acquistare (i docenti) non subisce poi l’onere della scelta, ovvero mettere mano al portafoglio.
Non sorprende, quindi, che ci sia da parte dei professori una certa disinvoltura nell’aggiornare le scelte adozionali: siamo nell’ordine del 35-40% alle scuole secondarie nell’ultimo anno scolastico, ma in passato si sono toccate punte del 40-50%. Facile intuire che la stabilità consentirebbe una maggiore circolazione dei libri usati e in comodato, di classe in classe nella stessa scuola.
Nuove edizioni che passione
Ma c’è anche un terzo aspetto che contribuisce a limitare il mercato dell’usato: le nuove edizioni dei libri. Esisterebbe un codice di autoregolamentazione sottoscritto dagli editori aderenti all’AIE - principale associazione di categoria - che impone modifiche di almeno il 20% dei “contenuti” tra la nuova e la vecchia edizione.
Tuttavia, l’AGCM sottolinea che questa formulazione consegna un ampio potere discrezionale nelle mani degli operatori, che si unisce all’assenza di controlli sia da parte dell’AIE che del Ministero dell’Istruzione. Così, le nuove edizioni proliferano un po’ alla volta - il 10% all’anno circa - e quindi il tasso di variazione a tre-cinque anni sale, rispettivamente, al 25% e a oltre il 40%.
Mercato dell’usato castrato
Il combinato di disposto di libri spesso e volentieri nuovi insieme ad adozioni che cambiano di continuo, secondo l’Antitrust, “erode in maniera consistente la riutilizzabilità dei libri già disponibili”.
Una quindicina di anni fa si era provato a mettere un freno al fenomeno, con una norma che imponeva il blocco delle adozioni per 5 o 6 anni, nonché l’adottabilità di libri per i quali l’editore si fosse impegnato a mantenere le edizioni invariate per lo stesso lasso di tempo. Con eventuali aggiornamenti che dovevano essere contemplati in fascicoli da vendere separatamente.
Una norma che sarebbe da recuperare e che invece è stata abolita per favorire, nel 2013, la transizione ai libri digitali, anche questi pensati per far risparmiare le famiglie.
Il digitale non fa risparmiare
In teoria. Perché il sogno di libri digitali da scaricare e stampare a casa - sulla base dei bisogni - con pochi euro di spesa è rimasto tale.
Infatti, da una parte si è scoperto che il libro digitale è un oggetto ben più complesso e che quello che si risparmia in carta lo si spende in piattaforme informatiche e sviluppo di contenuti multimediali e interattivi necessari per adattare il processo di apprendimento dalla carta agli schermi.
Investimenti che, peraltro, non tutti gli operatori sono stati in grado di sostenere, portando alla fusione-acquisizione di molti soggetti e la conseguente concentrazione del mercato in capo fondamentalmente a quattro soli gruppi.
Inoltre, mentre il libro cartaceo si può rivendere, quello digitale no. E peraltro è disponibile solo per periodi di tempo limitati - tipicamente 3 o 5 anni - e con tutta una serie di limitazioni di stampa, download e riproduzione dei contenuti per tutelare il diritto d’autore.
Il libro resta sempre di carta (e con tanti fogli)
A conti fatti, oggi il 90-95% dei libri adottati è di tipo misto, ovvero costituito dal classico formato cartaceo con una aggiunta di contenuti disponibili in digitale. Con tutte le limitazioni di cui sopra, ivi compresa la non trasferibilità dell’accesso dal primo proprietario al successivo.
Fortunatamente (?) i professori sembrano non essere così interessati al digitale, visto che in media solo l’11% dei possessori di libri misti accedono ai contenuti di approfondimento. Così le adozioni di libri esclusivamente in forma digitale, pur crescendo negli ultimi anni, si attestano in una quota compresa inferiore al 5%.
Inoltre, i nostri libri di carta sono anche quelli più ricchi di pagine rispetto a quello che avviene nel resto del mondo, perché i docenti hanno la facoltà di personalizzare le indicazioni nazionali del Ministero.
Tanta carta però vuol dire, soprattutto dopo il conflitto in russo-ucraino, tante materie prime e altrettanta energia da impiegare, con i relativi costi.
Fatta la legge, nessuno (o quasi) la rispetta
In ogni caso, dal 2008 esiste una legge che impone alle scuole di non superare un certo budget di spesa complessivo quando scelgono quali libri adottare: un tentativo di far mettere i docenti nei panni (o meglio nelle tasche) delle famiglie, purtroppo fallito.
Il Ministero dell’Istruzione si riservava, poi, la possibilità di adeguare questi tetti di spesa all’inflazione. Peccato che dal 2012 al 2025 nessuno ci abbia messo più mano, facendo pensare che in fondo fosse più una indicazione che un obbligo.
Convinzione corroborata da un’assenza di controlli ferrei, che hanno portato molti consigli di classe a sforare il budget oppure ad aggirare la norma con l’escamotage dei libri consigliati.
Per questo, conti alla mano, anche se i tetti di spesa sono rimasti invariati negli ultimi cinque anni scolastici, in realtà la spesa media teorica per studente è aumentata. Alle superiori, ad esempio, si è passati da 236 a 250 euro.
Peraltro con un paradosso: i prof del Sud fanno spendere mediamente di più alle famiglie di quelli del Nord.
Niente sconti, siamo italiani
Una legge che, invece, tutti rispettano è quella del tetto agli sconti praticabili sul prezzo di copertina: massimo il 15%. La norma è stata introdotta per tutelare alcuni canali di vendita tradizionali, come librerie e cartolibrerie, che ad un certo punto si sono trovate strette nella morsa dei grandi operatori online o della grande distribuzione
Questi ultimi erano, infatti, capaci di praticare sconti anche superiori, magari sotto forma di buoni spesa da impiegare successivamente sui medesimi canali.
Qual è stata la soluzione? Limitare lo sconto, con buona pace dei portafogli delle famiglie.
Non toccate il mio libro
Eppure ci sono materie in cui i libri potrebbero essere tranquillamente sostituiti da dispense autoprodotte dai docenti o da altre fonti: motivo per cui non è più obbligatorio adottare libri di testo.
Peccato che questa possibilità sia rara quanto un panda - avviene solo nell’1% dei casi - e soprattutto poco incentivata. I docenti che decidono di mettersi al servizio per l’autoproduzione di libri di fatto lo devono fare su base volontaria.
Ecco perché l’unico progetto di autoproduzione di rilevanza - Book in Progress - ha raggiunto una buona massa critica - oltre 70 istituti aderenti - ma non ha preso quote di mercato.
Eppure questa rete di scuole ha messo in piedi, con il contributo dei suoi docenti, una vera e propria casa editrice capace di far spendere, dove viene adottata, al massimo un centinaio di euro all’anno per tutta la dotazione libraria, che si presenta sia in formato cartaceo che digitale.
Aiuti di Stato spesi… male
Infine, ci sarebbero fondi per consentire alle famiglie meno abbienti di ricevere libri in comodato d’uso alle scuole medie e superiori. Ma queste somme - oltre 130 milioni di euro nell’ultimo anno - non sono sufficienti per coprire il fabbisogno reale.
Questo perché molte risorse vengono distratte da un’altra forma di sussidio, ovvero la fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole elementari. Una misura vitale per le famiglie con minori possibilità e che magari è ininfluente per famiglie più benestanti, a cui magari quel centinaio euro all’anno risparmiati non fanno poi tutta questa differenza.







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo