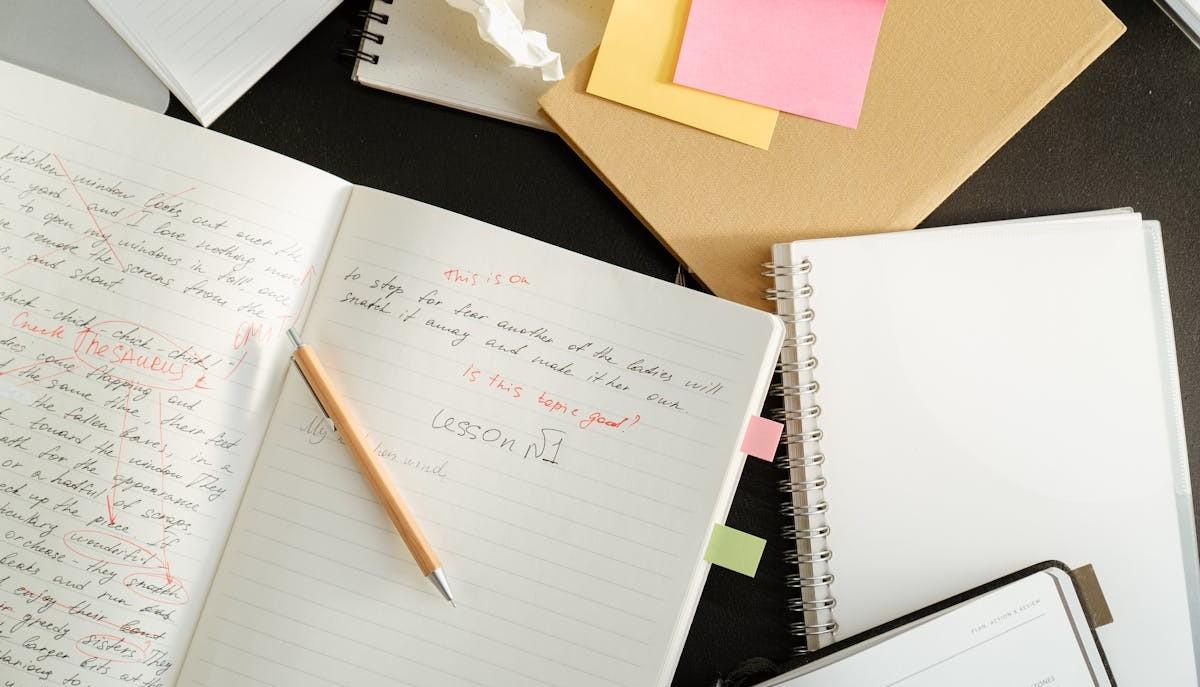
Una sfida è vinta: tenerli a scuola. Ora bisogna dargli le competenze, perché altrimenti il diploma di Maturità per alcuni di loro resta un pezzo di carta, soprattutto in alcune zone del nostro Paese, come Sicilia, Sardegna, Calabria e Campania. Ma anche a livello nazionale la situazione è tutt’altro che rosea, con quasi la metà (48,3%) degli studenti di quinto superiore che non raggiunge il livello minimo atteso in italiano e addirittura oltre tale quota (50,8%) che si ferma sotto la “misura” accettabile per quanto riguarda la matematica. Con un divario che, nel caso della disciplina tecnica, tra Nord e Sud tocca i 23 punti percentuali.
Tradotto in termini pratici, circa 1 giovane su 2, giunto al termine della propria esperienza scolastica, non riesce a comprendere un testo in lingua italiana come ci si aspetterebbe dopo tredici anni di lezioni e verifiche. Lo stesso, se non peggio, dicasi per la capacità logico-matematiche.
Questo nonostante la battaglia contro la dispersione scolastica “esplicita” stia dando i suoi buoni frutti. Dati alla mano, dal 2018, il numero di studenti che abbandonano prematuramente la scuola è in calo: secondo le stime, in questi pochi anni si è passati dal 25,3% all’8,3%. Ma, forse, è proprio questa l’origine dell’apparente ineluttabilità di quella “implicita”: aumentando la popolazione di riferimento, portare un maggior numero di persone verso alti livelli di competenze diventa più complicato.
Indice
- Il lato positivo del Rapporto INVALSI: meno dispersione e inglese in ripresa
- Ma il diploma resta spesso vuoto: crescono i “dispersi impliciti”
- Le risposte del MIM: interventi mirati per non perdere altri studenti
- Nord e Sud, due Italie a confronto su italiano e matematica
- La lingua straniera salva (parzialmente) il bilancio, ma non basta
- Educazione: perché iniziare prima fa la differenza
- L’ascensore sociale? Fermo
Il lato positivo del Rapporto INVALSI: meno dispersione e inglese in ripresa
È, dunque, un quadro dal sapore agrodolce quello che emerge dalla presentazione del Rapporto Nazionale INVALSI del 2025. Perché, va detto, sullo sfondo si fanno strada almeno un paio di buone notizie: da una parte, come detto, la riduzione del numero di studenti che lasciano la scuola prima della Maturità - al punto da far presumere che già quest’anno potremmo raggiungere l’obiettivo del 9% fissato per il 2030 a livello europeo -, dall’altra la conferma dell’andamento positivo registrato nelle competenze di lingua inglese, unica materia in cui l’intera nazione sembra relativamente salvarsi.
Entrambi i risultati sono notevoli, parliamo infatti di miglioramenti di diversi punti percentuali, in particolare per la dispersione scolastica: a inizio millennio mollava oltre 1 giovane su 4, ora stiamo sotto 1 su 10.
Ma il diploma resta spesso vuoto: crescono i “dispersi impliciti”
Purtroppo, però, facciamo ancora una grande fatica a trasformare questi titoli accademici in competenze reali: oltre al dato generale sugli studenti che non raggiungono in quinta superiore i livelli minimi attesi in una delle quattro aree monitorate dall’INVALSI - italiano, matematica, inglese lettura e scrittura - colpisce quello dei “dispersi impliciti”.
Stiamo parlando di coloro che simultaneamente non riescono a raggiungere “la sufficienza” in tutti e quattro gli ambiti: per tutti loro è molto probabile che il diploma rimanga un pezzo di carta. Così, dopo la lieve flessione dello scorso anno, il dato torna a salire, raggiungendo l’8,7% su scala nazionale. A preoccupare di più, però, è ancora una volta la situazione nel Mezzogiorno, dove il dato aumenta: qui, la dispersione implicita tocca il 14,1%, ben oltre la media nazionale.
Le risposte del MIM: interventi mirati per non perdere altri studenti
Il perché di questo fenomeno, come detto, è presto spiegato: si riescono a trattenere maggiori quote di studenti nel sistema scolastico rispetto al passato, ma nel contempo si fa fatica a portare questi alunni fragili, dal punto di vista socio-culturale, ad un livello accettabile di competenze. Una soluzione c’è, però. E la si può trovare nei programmi Agenda Sud e Agenda Nord varati dal MIM, che hanno previsto finanziamenti nelle scuole che versano in condizioni critiche dal punto di vista dei risultati INVALSI, con l’obiettivo di ridurre la dispersione implicita (come anche quella esplicita).
Quindi niente interventi a pioggia, ma interventi mirati lì dove serve secondo le rilevazioni statistiche. Anche perché la situazione generale è diversa da regione a regione, da città a città, da famiglia a famiglia. Due esempi di ciò? Gli studenti provenienti da contesti più agiati dal punto di vista socio-economico se la cavano meglio degli altri, mentre le regioni del Nord svettano sul resto d’Italia.
Nord e Sud, due Italie a confronto su italiano e matematica
Tornando ai principali esiti dettagliati della rilevazione INVALSI, solo per gli studenti del Nord Est e del Nord Ovest la comprensione dei testi scritti raggiunge livelli almeno accettabili, rispettivamente il 60,9% e il 60,1% degli alunni. Al Centro la percentuale già scende al 49,8%. Per fermarsi a un preoccupante 43,7% nel Mezzogiorno, specie nel versante “tirrenico” del Sud e nelle Isole, dove arretra ulteriormente al 43,3%.
In matematica i risultati medi sono ancora più bassi: circa 5 punti percentuali in meno rispetto al 2019, confermando una tendenza internazionale già osservata in molti Paesi OCSE europei e nordamericani, dove le competenze in matematica sono in calo. E, anche qui, il divario territoriale è più che evidente. Nel Nord Ovest è il 58,8% degli studenti a raggiungere risultati almeno adeguati, nel Nord Est si sale al 61,5%. Al Sud, invece, il crollo è drastico: solo il 40,4% supera il livello minimo richiesto. Ma, di nuovo, è nelle Isole che si tocca uno dei punti più bassi, con appena il 38,1%.
La lingua straniera salva (parzialmente) il bilancio, ma non basta
E i numeri sarebbero ancora peggiori se non si fosse confermato l’andamento in positivo - rispetto al periodo post-pandemico - in lingua inglese, che ha consentito ad alcuni alunni che l’INVALSI definisce ‘fragili’ di uscire fuori da questa condizione per via appunto della buona prestazione nella lingua straniera. Anche se - va detto - rispetto al 2024 si registra una leggera flessione in tutti i territori. Nella prova di Ascolto che l’evoluzione positiva degli esiti è più evidente, anche se permangono forti divari territoriali.
La strada da fare per ritenersi soddisfatti rimane comunque in salita. Questo perché non siamo ancora tornati ai livelli di competenze pre-pandemia in italiano e matematica in qualsiasi grado di istruzione misurato dall’INVALSI: dalla quinta superiore fino alla seconda elementare. A tal proposito, va evidenziato un dato curioso: come fanno bambini che cinque anni fa erano a casa o nella scuola dell’infanzia ad avere un ritardo di competenze a causa del minor tempo speso in un luogo che, ad oggi, è facoltativo?
Educazione: perché iniziare prima fa la differenza
Evidentemente quelli che comunemente si chiamano asili e nidi - tecnicamente i servizi educativi 0-6 anni - non sono un semplice parcheggio per bambini, come alcuni erroneamente credono. Lo confermano anche studi internazionali: tra l’andare a scuola in questa fascia d’età e il non andarci c’è una bella differenza e questi dati lo dimostrano. Soprattutto perché intorno ai 3 anni di vita il nostro cervello raggiunge la massima neuroplasticità di tutta la sua esistenza.
Senza contare che negli ultimi cinque anni anche i piccolissimi hanno fatto una scorpacciata di digitale sicuramente superiore rispetto a quello che avveniva in passato, con i relativi possibili problemi di sviluppo cognitivo. Anche se su questa congettura “l’INVALSI non ha gli strumenti per poter formulare ipotesi scientifiche a riguardo”, afferma Roberto Ricci, Presidente dell’Istituto, a precisa domanda.
L’ascensore sociale? Fermo
Il rapporto INVALSI, invece, può sicuramente confermare che le differenze di origine territoriale e familiare iniziano fin dai primi gradi di scuola e proseguono, aumentando, fino al termine del percorso di studi.
Insomma, la scuola italiana non riesce a contribuire, sui grandi numeri, all’ascensore sociale: purtroppo sono pochi i territori che garantiscono un sistema scolastico equo, ovvero risultati medi elevati per la maggior parte degli studenti. E sono essenzialmente le regioni a statuto speciale e le province autonome del Nord.
Quindi la sfida, ribadisce Roberto Ricci, è quella di adottare interventi mirati per riportare in equilibrio il sistema che ad oggi è un po’ come “un’automobile dove prima c’erano quattro passeggeri e oggi ce ne sono cinque: il livello dei pneumatici si abbassa. La sfida è di portarli al livello precedente, per evitare di bucare”.





.jpg)

 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo