Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
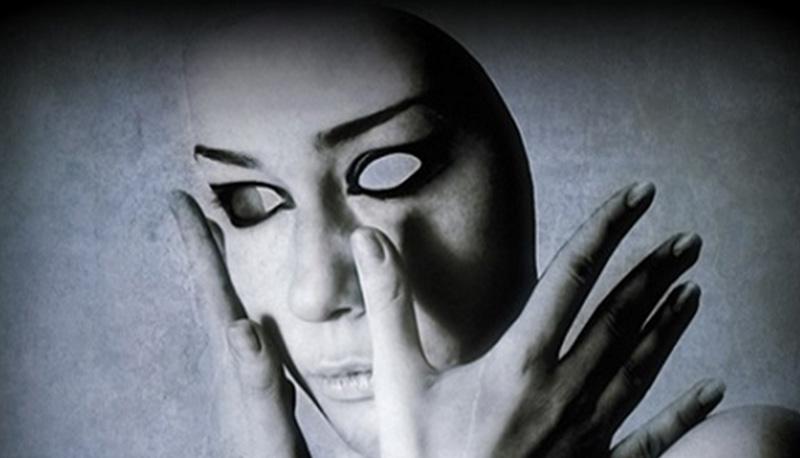
Realtà ed apparenza
dall’essere tradotti in un linguaggio artistico, come se Apollo desse
forma ai contenuti di Dioniso.
E la tesi nietzscheiana, che campeggia nell’opera, secondo la
quale la tragedia deriverebbe da antichi riti dionisiaci, è ancor oggi
accettata.
Tragedia, infatti, sta a significare “canto del capro”: il capro era
un animale sacro a Dioniso; al coro di uomini vestiti come capri in onore
del dio, si è sempre più contrapposta la figura di Dioniso e da ciò si è,
gradualmente, sviluppata la tragedia vera e propria.
In quest’opera Nietzsche professa la propria ascendenza
schopenhaueriana e lo si evince dal prevalere, nella sua lettura del
mondo greco, dell’aspetto drammatico e caotico dell’esistenza e della
forza irrazionale, quasi demoniaca, che la permea a tal punto che la
razionalità altro non è se non una mera apparenza.
Tuttavia, nella seconda edizione dell’opera, Nietzsche pone una
prefazione in cui dichiara di non subire più l’influsso schopenhaueriano.
I due filosofi appaiono incommensurabilmente distanti nella loro
concezione della vita; essa è per Nietzsche il valore centrale intorno al
quale costruire la filosofia e va vissuta accettandola in ogni sua
sfumatura (in “Così parlò Zarathustra” egli dice, con un’espressione che
ben sintetizza la sua filosofia, “bisogna avere un caos dentro di sé per
generare una stella danzante”), mentre per Schopenhauer, attraverso
quel tortuoso processo che, culminando con la “noluntas”, porta allo
spegnimento della vita stessa, essa non ha alcun valore, ed è anzi la
fonte della sofferenza umana.
Da tutto ciò si evince come per Nietzsche la vita sia il valore
supremo e che la tragicità che la connota non sia un motivo sufficiente
per sottrarsi ad essa: il coro tragico si identifica a tutti gli effetti con la
caoticità di Dioniso; Apollo stesso, del resto, non viene dipinto a tinte
negative, ma è inteso come un filtro che permette di vedere la tragicità
esistenziale senza essere accecati dal fulgore che essa emana.
Ciò non toglie, tuttavia, che l’apollineo, per rimanere positivo,
non debba perdere il suo contatto con il dionisiaco (da cui è generato):
9
il problema sorge nel momento in cui Apollo non è più portavoce di
Dioniso, ma parla con voce propria, diventando così autonomo.
E il crollo della cultura greca, verificatosi agli occhi di Nietzsche
nel V secolo a.C. è legato proprio a questo: i due personaggi che ne
sono vessilliferi sono Euripide, tragediografo dell’epoca, e Socrate,
modello tipico di spettatore di tali tragedie.
Infatti, con la produzione euripidea, il tragico sfuma e cede il
passo alla razionalità, i personaggi in scena ragionano con una
dialettica spietata e la tragedia perde i suoi connotati tragici tendendo
sempre più a diventare ottimistica e razionale.
Socrate, dal canto suo, è il primo grande simbolo della
razionalità filosofica della Grecia e il suo allievo, Platone, non fa che
accentuarla: la civiltà occidentale si è sempre più diretta, in modo
irresistibile, verso una marcata compostezza ordinata e razionale, con il
conseguente sganciamento dell’apollineo dal dionisiaco e la fine
dell’equilibrio tra i due.
In questa fase del suo percorso filosofico, Nietzsche, scorge nella
figura di Wagner la possibilità di una rinascita della tragedia greca,
intesa come antidoto al prevalere imperante dell’apollineo.
Una buona parte del lavoro filosofico di Nietzsche nella sua
maturità è dedicato alla ricostruzione della “genealogia della morale”:
se nella prima fase della sua indagine, il pensatore tedesco aveva
individuato nell’arte la via di salvezza per la civiltà occidentale, da un
certo momento in poi egli abbandona tale strada e scorge l’unico
antidoto possibile nella scienza; per questo motivo questa nuova
stagione del suo pensiero è stata spesso definita “illuministica”.
Apparentemente può stupire questa fedele adesione alla scienza
di un pensatore che privilegia l’irrazionale e, soprattutto, il vitalismo.
Ma l’atteggiamento che egli assume è radicalmente diverso
rispetto a quello positivistico, fiducioso che nel dato di fatto risiedesse
la verità; più precisamente, la valutazione positiva che Nietzsche riserva
alla scienza è perché non la considera in base ad un criterio di verità,
ma piuttosto perchè capace di liberare l’uomo, proprio come, anni
10
prima, aveva valutato positivamente la religione per la sua capacità di
far emergere la capacità creativa.
E’ per questo che egli abbraccia la scienza nella misura in cui in
essa scorge una capacità liberatoria, senza contrapporla, perchè più
“vera” (come invece facevano i positivisti) alle nebbie della metafisica.
Ciò che più affascina Nietzsche della scienza e del suo essere
utile per la vita è il fatto che essa indaghi sull’origine delle cose.
Nietzsche vuole invece proiettare la propria indagine sulla
morale, e vuole dimostrare che essa non ha un’origine sovrasensibile e
divina, ma anzi, fin troppo terrena: le regole morali che serpeggiano
nella nostra civiltà sono regole di convivenza civile per regolare il
comportamento degli individui, e non leggi enigmaticamente emanate
da Dio. La morale nasce perché l’uomo, ha per natura il bisogno di
dominare la realtà che lo circonda.
E, per fare ciò, sente la necessità impellente di imporsi delle
regole comportamentali e conoscitive che lo difendano dalla realtà
caotica e irrazionale in cui è immerso, proprio come, al tempo dei Greci,
lo spirito apollineo era nato da quello dionisiaco.
Perfino la religione è una forma di morale, visto che in Dio sono
cristallizzati tutti i valori maturati nella storia dell’uomo; quelli che
vengono generalmente riconosciuti come “il bene” e “il male” sono tali
perchè così hanno stabilito i “padroni”: succede, così, che nasca una
morale dei servi, di coloro, cioè, che sono assoggettati in quanto deboli
e che, con la loro morale, intendono negare la validità del diritto del più
forte, proponendo, opposta ad essa, una “morale del risentimento”.
Nietzsche demitizza la morale e da ciò deriva un atteggiamento
di nichilismo.
Una volta che la scienza “gaia” (perchè liberatrice) perviene alla
conoscenza e alla decostruzione della morale, la depotenzia fino a
liberare l’uomo dalle tradizionali catene dei valori morali imposti
dall’esterno con la “trasvalutazione dei valori”, ovvero l’affermazione
che la verità in realtà è menzogna. 11
In base a tali considerazioni, Nietzsche può così arrivare ad
affermare che “Dio è morto”: in molti si sono chiesti perchè non dica,
molto più semplicemente, che non esiste, ma in realtà il suo
atteggiamento è profondamente motivato dal suo stesso impianto
filosofico.
Dopo che la morale e la religione sono giunte al loro crepuscolo,
l’uomo che si è congedato da esse è il superuomo; “morti sono tutti gli
dèi: ora vogliamo che il superuomo viva”.
Tuttavia, al termine superuomo, destinato a diventare un mito
per le generazioni successive a Nietzsche e ad essere soggetto di
clamorosi fraintendimenti, è preferibile usare quello di “oltreuomo”.
Fondamentalmente, l’oltreuomo non è un essere superiore agli
altri, ma la nuova figura che l’uomo dovrà assumere in futuro.
Zarathustra insegna a non accettare insegnamenti, e a creare
nuovi valori; profetizza la venuta del superuomo: “Ancora non é esistito
un superuomo. Io li ho visti tutti e due nudi, l’uomo più grande e il più
meschino. Sono ancora troppo simili l’uno all'altro. In verità anche il più
grande io l’ho trovato troppo umano!”.
Vi sarà una fase provvisoria in cui esisteranno solo pochi
oltreuomini in grado di cogliere come procede il futuro.
L’oltreuomo trasvaluta tutti i valori e ne crea di nuovi, facendo
della propria vita un’opera d’arte.
Nietzsche può affermare che “l’uomo è un cavo teso fra la bestia
e il superuomo [...] é qualcosa che deve essere superato”, ma tale cavo
è sospeso nel vuoto ed è perciò un passaggio arduo e rischioso (non a
caso il funambolo presente in “Così parlò Zarathustra” perde l’equilibrio
e cade).
Sempre dalla lettura di “Così parlò Zarathustra” emergono altri
concetti chiave della filosofia nietzscheiana, come ad esempio quello di
“Volontà di potenza” e di “Eterno ritorno”.
In particolare, la Volontà di potenza è l’elemento dionisiaco in
grado di cogliere la forza irrazionale che governa la realtà e che finiva
per identificarsi con la Volontà di Schopenhauer.
12
Tuttavia, con la nozione di “Volontà di potenza”, Nietzsche si
discosta dall’insegnamento del filosofo pessimista che insisteva
vivamente sulla necessità di capovolgere la Volontà in “noluntas”, quasi
come se si dovesse sfuggire alla Volontà stessa; Nietzsche sostiene
invece che si deve accettare fino in fondo la tragicità dell’esistenza e
trovare una specie di gioia paradossale nel vivere il caos fino in fondo.
E, con l'avvento del nichilismo, la mancanza di un senso assoluto
finisce, secondo Nietzsche, per far assumere un senso assoluto proprio
a quella realtà superficiale che è il mondo che ci circonda.
L’oltreuomo si trova nella situazione in cui non ci sono più
l’essere né i valori prestabiliti, e ad esistere sono solamente le
interpretazioni del mondo.
“Non esistono fatti, ma solo interpretazioni”. Non vi è una verità
oggettiva da guardare sotto diversi profili, ma vi sono solo più i punti di
vista. L’ultimo concetto del filosofo è quello di “Eterno ritorno”: è la
teoria dell’eterno ritorno all’uguale, la ripetizione eterna di tutte le
vicende del mondo; credere all’eterno ritorno è disporsi a vivere la vita
e ogni attimo di essa, come coincidenza di essere e senso.
L’uomo capace di vivere come se tutto dovesse ritornare non può
essere l’uomo che noi conosciamo, che vive con angoscia la vita, ma un
oltreuomo in grado di vivere la vita come un gioco creativo avente in se
medesimo il proprio senso appagante.
13
LUIGI PIRANDELLO: ILLUSIONE E REALTA’
Scrittore, drammaturgo e narratore,
rappresentò sulle scene l’incapacità
dell’uomo di identificarsi con la propria
personalità, il dramma della ricerca di
una verità al di là delle convenzioni e
delle apparenze.
Al centro della concezione
pirandelliana c’è il contrasto tra
apparenza e sostanza. La critica delle
illusioni va di pari passo con una
drastica sfiducia nella possibilità di
conoscere la realtà: qualsiasi
rappresentazione del mondo si rivela
inadeguata all’inattingibile verità della
vita, percepita come un flusso
continuo, caotico e inarrestabile.
La posizione fondamentale dalla quale è necessario partire per
capire la concezione della vita di Pirandello e quindi la sua poetica, è
quella del contrasto tra illusione e realtà.
L’esperienza pirandelliana è quella di tutta la generazione dei
decadenti, cioè di uomini che avevano visto vanificare gli ideali
ottocenteschi di progresso, scienza, di pacifica collaborazione tra gli
uomini, e si trovavano a vivere una realtà storica ben diversa, avviata
verso la catastrofe della 1° Guerra Mondiale.
In seguito a ciò, nacque la convinzione del fallimento. La vita si
presentava assurda nella sua casualità e tale che ogni illusione era
destinata a mostrare il suo risvolto negativo.
14
Pirandello sostiene che, il contrasto tra apparenza e realtà, non
esiste solo fuori di noi, ma anche e soprattutto nell’intimo della
coscienza: contrasto tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere, tra
ciò che siamo e ciò che risultiamo agli occhi degli altri, perchè “la vita è
un flusso che noi cerchiamo di arrestare in forme stabili e determinate”
come i concetti, gli ideali...
Di conseguenza ciascun personaggio presenta centomila realtà
interne, per cui la vera realtà è nessuna. Tra realtà e non-realtà ci sono
due distinte dimensioni:
la dimensione della realtà oggettuale, ovvero la realtà
esterna agli individui, apparentemente è uguale e valida per tutti,
presenta per ognuno le stesse caratteristiche fisiche ed è la non-
realtà inafferrabile e non riconoscibile.








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









