"...Io so che Antonio è triste perché pensa alle sue mercanzie. No credimi ringrazio la fortuna: i miei investimenti non sono affidati a una sola nave o a un solo approdo, ne tutti i miei averi dipendono dalla fortuna di quest'anno..." Il Mercante di Venezia, AttoI° Scena I°.

Qualcuno ha scritto che Shakespeare è ampio quanto il mondo certo è che nei suoi drammi storici e in alcune tragedie si può trovare molto sulla gestione del potere e sugli stili di leadership nelle organizzazioni:
Riccardo II° è convinto che possedere il titolo di Re per diritto divino gli dovrebbe assicurare l'obbedienza dei sudditi;
Re Lear pensa che anche dopo aver ceduto agli eredi la sua terra il sangue reale gli garantisca un potere illimitato; Antonio crede che il potere affidatogli dipenda unicamente dalla sua persona e non dalla istituzione (l'impero romano) che glielo ha delegato;
Riccardo III° è spinto dalla sua ambizione a pensare che potrà ottenere ciò che vuole;
Macbeth mostra come dietro il potere e la determinazione di un grande uomo (nel bene e nel male) ci sia spesso una donna;
Coriolano è sempre in prima linea nella gestione dei conflitti più duri mostrandosi coraggioso, ma anche implacabile e vendicativo;
Enrico V° considera determinante per la sua leadership ascoltare i propri uomini e saperli motivare. (vedi: P. Carrigan, Shakespeare e il management, Etas, Milano 2002). Antonio, il Mercante di Venezia, esordisce ricordando che i suoi investimenti sono ben distribuiti nello spazio e nel tempo anticipando concetti moderni come la diversificazione e la globalizzazione dei mercati. Le vicende narrate lo contrappongono all'usuraio ebreo Shylock che gli ha prestato del denaro essendo tutti i suoi averi immobilizzati nelle attività commerciali. E' interessante ricordare che la parola usuraio deriva dal latino usum (cioè colui che dà in uso il denaro) ed è comprensibile che chi dà in uso (affitto, comodato, leasing, prestito,ecc.), per un certo tempo, un bene debba essere adeguatamente remunerato (vedi anche in questa stessa sezione la parabola dei talenti). Nel moderno sistema economico finanziario occidentale si legittima il tasso d'interesse, ma si condanna il suo valore troppo elevato come reato di usura. Shylock si oppone ad Antonio anche perché la consuetudine del Mercante di prestare gratuitamente denaro agli amici gli rovina il mercato (oggi si parla molto di mercato drogato, sussidi di stato ecc.).
Contro l'avanzata della classe mercantile che esaltava i valori della industry, ossia del lavoro produttivo e delle nuove pratiche finanziarie, il vecchio ordine si difendeva con i diritti della nobiltà ereditaria, dei privilegi di sangue e delle proprietà terriere. E' proprio Porzia, una donna ereditiera delle terre di Belmonte, il terzo attore economico di questa commedia; è lei a comprendere la situazione, i problemi e a portarli a soluzione con sagacia ed intelligenza. Shakespeare, esponente della nuova borghesia, ma con potenti amici aristocratici, non fa trapelare la sua preferenza tra questi tre personaggi in quanto la scelta è fra la nuova etica capitalistica che si affaccia e quella tradizionale che tutela gli antichi privilegi. (vedi: A . Marzola, La Parola del Mercante, Bulzoni 1996; G. Melchiori, Shakespeare: politica e contesto economico, Bulzoni 1992).


![Il foglio elettronico per rappresentare e risolvere problemi [Bob Frankston]](https://cdn.skuola.net/shared/thumb/159x141/news_foto/images/stories/problem_solving/bob.frankston.png)
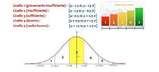
![Serendipity, la scoperta della penicillina e degli antibiotici [A. Fleming]](https://cdn.skuola.net/shared/thumb/159x141/news_foto/images/stories/problem_solving/ewan-alexander_fleming.jpg)





 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo