Concetti Chiave
- Il confronto tra Roma e Grecia è un tema centrale, evidenziando il nazionalismo romano e il continuo rapporto di diffidenza, apertura e ammirazione verso la cultura greca.
- La missione di Roma era di esercitare il potere con clemenza verso i vinti e fermezza verso i superbi, promuovendo un governo mondiale pacificatore sotto la propaganda augustea.
- La "Gens Iulia" è celebrata attraverso il commosso ricordo di Marcello, riflettendo l'encomio verso le glorie di Roma e l'umanità di Augusto, segnato dal dolore personale.
- Virgilio, attraverso la sua sensibilità, rende gli eroi come Enea e Augusto umani e vicini ai lettori, enfatizzando la sofferenza condivisa e la loro grandezza al servizio di Roma.
- Il testo presenta Roma come una città quasi onnipotente, capace di governare sopra le maggiori potenze del mondo antico, dimostrando la sua imponenza storica.
Confronto con la Grecia
Uno degli aspetti più rilevanti che possono essere sottolineati e sicuramente quello del confronto tra l’antica Roma e l’antica Grecia. Le parole di Anchise ai vv. 847-853 sono un solenne monito (memento, v. 851) rivolto ai Romani e hanno una connotazione fortemente nazionalistica, rivendicando la grandezza di Roma rispetto al modello straniero, in particolare quello greco. Il confronto con la Grecia fu infatti sempre vivo a Roma e formato da diversi atteggiamenti come: ora diffidenza (
Catone il Censore), ora apertura e interesse (circolo degli Scipioni), ora ammirazione (
Cicerone). Orazio il poeta augusteo coevo di
Virgilio, sintetizzò in due celebri versi il rapporto fra Roma e Grecia, sottolineando il processo di osmosi culturale tra i due popoli: Grecia capta ferum victorem cepit et artes / intulit agresti Latio (Epistulae, II, 1, vv. 156-157), “Conquistata, la Grecia introdusse nel rustico Lazio le arti / e la vinse sui vincitori selvaggi” (trad. U. Dotti).
Missione di Roma
A prescindere dai singoli destini e dalle diverse virtù delle figure storiche che si avvicenderanno, per i Romani una soltanto sarà l’ars da coltivare ed esercitare collettivamente: il potere, con atteggiamento clemente verso i vinti e inflessibile verso i superbi, un governo del mondo che quindi non si basa soltanto sulle armi, ma che sa anche proporre le opere della pace. I termini sono quelli della missione pacificatrice che Roma si attribuisce nella propaganda augustea a partire dalla battaglia di Azio del 31 a.C.
Gens Iulia
Il commosso ricordo di Marcello, che chiude la rassegna degli eroi futuri, ha anch’esso una funzione ideologica. Dietro le lacrime di Anchise si celano quelle dello stesso Augusto che, secondo le fonti, fu preso da profonda commozione quando ascoltò la lettura di questi versi insieme con la sorella Ottavia. Il princeps perde il giovane da lui designato come successore, e come Enea ha visto morire tantissimi e soprattutto giovani eroi, quasi vittime sacrificali per propiziare la gloria di Roma. Se il senso di tutto il passo è encomiastico nei confronti della gens Iulia e delle glorie di Roma, in questi ultimi versi l’attenzione di Virgilio, dettata dalla sua sensibilità e dalla sua humanitas, è principalmente per la dimensione privata e umana di Augusto, il cui destino, come quello di Enea e di ogni comune mortale, è intessuto di dolore. In tal modo i due eroi, celebrati per la loro grandezza al servizio di Roma, proprio per la sofferenza che condividono sono resi più umani e più vicini a tutti gli uomini e a tutti i lettori dell’épos virgiliano. Da questo testo, quindi abbiamo potuto vedere come emerge una visione dell’antica Roma vista come una città che può essere definita quasi onnipotente. Infatti era in grado di governare al di sopra delle maggiori potenze mondiali dell’epoca. Potremmo anche dire che Roma stessa era una delle potenze più imponenti di quel periodo.

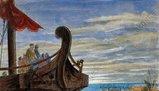







 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo