vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
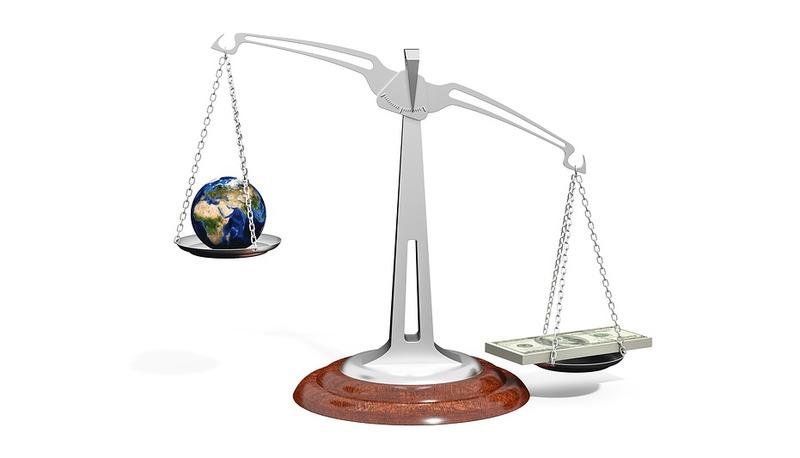
I.T.I.S. “J. TORRIANI” – CREMONA
Laboratorio di Fisica
Allievo: Data: 15.03.2007
Classe: 2ªB LST Esercitazione n° 13
Gruppo: Bencivenga Salvatore,
Cristofoletti Miriam,
Lorenzini Lara,
Lorenzini Marco,
Tomasoni Alice.
Titolo: Principio di conservazione della massa
Obiettivi:
1. Verificare che la massa di un corpo è indipendente dal suo volume.
2. Verificare il principio di conservazione e di additività della massa.
3. Imparare a misurare le masse e ricavare le leggi quando si mescolano più sostanze.
Richiami teorici:
CHIMICA = scienza che studia le proprietà, la composizione, la preparazione, la capacità e il modo di
reagire delle sostanze naturali e artificiali del regno inorganico e di quello organico.
SOSTANZA PURA = materiale costituito da un unico componente (ad esempio l’ossigeno); può essere:
COMPOSTO
- un “soluzione” dove non posso far variare il rapporto solvente – soluto;
→
ELEMENTO
- un sostanza pura più piccola che si può avere (valori tabulati).
→
MISCUGLIO = materiale costituito da più componenti (ad esempio l’aria: azoto, ossigeno, anidride
carbonica,…); può essere:
OMOGENEO SOLUZIONE
- ( ) non è possibile distinguere i componenti di cui è formato; composto da
→
SOLVENTE SOLUTO
(sostanza che “fa sciogliere”), e un (sostanza che “scioglie”);
un
ETEROGENEO
- è possibile individuare la presenza di più componenti.
→
SOLUZIONE SATURA = soluzione che non è più in grado di contenere il soluto (non è più in grado di
“sciogliere”); ciò dipende dalla temperatura maggiore è la temperatura, maggiore è la saturazione.
⇒
SOLUBILITÀ = quantità massima di soluto che si può sciogliere in una soluzione.
REAGENTI PRODOTTI
REAZIONE CHIMICA = fenomeni chimici (caratterizzati da e da ) all’interno dei
quali permane la conservazione della massa.
ESPERIENZA sull’INDIPENDENZA DELLA MASSA RISPETTO AL VOLUME
Strumentazione:
anello di riscontro
fornellino elettrico
sfera d’acciaio
bilancia elettronica
Modo di operare:
schema:
verificare che la sfera passi attraverso
l’anello di riscontro;
misurare la massa della sfera;
scaldare la sfera;
ripesare la massa della sfera;
verificare se la sfera passa per l’anello di riscontro.
descrizione:
Per iniziare l’esperienza, ci siamo accertati che la pallina d’acciaio passasse attraverso l’anello di ri
scontro. Dopo questa verifica abbiamo pesato la sferetta e annotato la sua massa, (189,33 ± 0,01)
grammi. Successivamente, abbiamo riscaldato il corpo ponendolo sul fornellino, ed abbiamo poi cer
cato di farlo nuovamente passare per l’anello di riscontro; questo secondo tentativo ha avuto un
esito negativo. Dopo questa seconda verifica abbiamo ripesato la sfera per accertarci che la mas-
sa non fosse variata.
Osservazioni che portano alle conclusioni:
- Il motivo per cui la sfera riscaldata non passa per l’anello di riscontro è che il calore l’ha fatta dilatare,
aumentando così il suo volume.
- Il principio di conservazione della massa di un corpo è dimostrato dal fatto che il volume della sfera
riscaldata è variato, ma è rimasta costante la sua massa; con questo possiamo affermare che la massa
rimane costante indipendentemente dalla variazione del suo volume.
ESPERIENZA sul PRINCIPIO DI ADDITIVITÀ E DI CONSERVAZIONE
DELLA MASSA: 1°esperimento
Strumentazione:
sale (contenuto in un pezzo di carta)
becker d’acqua
bilancia elettronica
Modo di operare:
schema:
mettere il sale su un pezzo di carta;
versare l’acqua nel becker;
misurare la massa complessiva;
mettere il sale nell’acqua;
aspettare che il sale entri in soluzione con l’acqua;
pesare nuovamente il tutto.
descrizione:
Per iniziare l’esperienza, abbiamo posto un po’ di sale su un foglietto di carta e versato dell’acqua
in un becker, misurando la massa del complesso (acqua, sale, becker, carta = (364,36 ± 0,01) g). Do
po aver annotato la massa, abbiamo fatto sciogliere il sale nell’acqua, aspettando che entri in solu-
zione con essa, facendo diventare il tutto una soluzione omogenea. Successivamente, abbiamo pe-
sato la massa di tale miscuglio, il suo recipiente e il foglietto di carta (364,32 ± 0,01) g, confron-
tandola con il valore registrato precedentemente.
Osservazioni che portano alle conclusioni:
- Anche dopo la reazione chimica tra acqua e sale, la massa complessiva ha mantenuto lo stesso valore.
- Abbiamo ottenuto un secondo valore che non rientra nel campo di errore del primo, perché abbiamo at-
teso troppo tempo prima di ripesare la massa complessiva: parte dell’acqua è evaporata, e non siamo quin-
di riusciti a rilevare un risultato soddisfacente.
ESPERIENZA sul PRINCIPIO DI ADDITIVITÀ E DI CONSERVAZIONE
DELLA MASSA: 2°esperimento
Strumentazione:
ioduro di potassio KI
→
nitrato di piombo Pb(NO )
→ 3 2
bilancia elettronica
2 becker
carta da filtro
sostegno con imbuto
Modo di operare:
schema:
mettere del nitrato di piombo e del ioduro di
potassio in 2 becker diversi;
pesarli insieme;
miscelare l’uno con l’altro;
pesarli nuovamente.
descrizione:
Per iniziare l’esperienza, abbiamo preso dei campioni di nitrato di piombo e di ioduro di potassio e
li abbiamo messi in due becker differenti. Abbiamo, successivamente, rilevato la loro massa com-
plessiva, risultando essere pari a (81,29 ± 0,01) g. Infine, abbiamo fatto avvenire una reazione chi-
mica, miscelando le due sostanze, ed abbiamo verificato che il risultato ottenuto dalla misura della
massa di quest’ultimo miscuglio, sommato alla massa dei due becker, fosse uguale al valore rilevato
in precedenza.
Risultati ottenuti:
EQUAZIONE CHIMICA da bilanciare: KI + Pb(NO ) KNO + PbI
→
3 2 3 2
EQUAZIONE CHIMICA bilanciata: 2KI + Pb(NO ) 2KNO + PbI
→
3 2 3 2
Osservazioni che portano alle conclusioni:
- Per vedere i componenti della miscela (diventato un MISCUGLIO ETEROGENEO), si possono applicare
due procedimenti:
metodo di filtrazione
- con la carta da filtro, che separa (se a grana grossa più rozzamente, se a gra
→
na fine più precisamente) la parte più liquida (nitrato di potassio), che scende attraverso l’imbuto nel re
cipiente sottostante, da quella più densa (ioduro di piombo), che invece, rimane depositata nella stessa;
metodo di centrifugazione
- mediante la centrifuga, che fa agitare le sostanze, fino a quando non si
→
deposita la parte più densa, sul fondo; poi, con una pipetta, si asporta la sostanza più in superficie.
ESPERIENZA sul PRINCIPIO DI ADDITIVITÀ E DI CONSERVAZIONE
DELLA MASSA: 3°esperimento
Strumentazione:
beuta contenente acqua
pastiglia effervescente “Vivin C”
bilancia elettronica








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo









