Concetti Chiave
- Dante's exploration of divine order in the Primo Mobile presents a paradox of angelic hierarchies, where the closest circle to God is the smallest yet most powerful.
- De Sanctis critiques Dante's Paradiso for its challenge in depicting the divine, suggesting that Dante's portrayal should transcend form to capture the divine's essence.
- The representation of the divine in Dante's work aims to visually translate pure abstraction, challenging the notion that such portrayals lack poetic merit.
- Dante's descriptive art in the Divine Comedy balances mysticism with objectivity, using vivid imagery to convey both personal and theological insights.
- The depiction of the angelic vision emphasizes the dynamic motion of angels and the static nature of the supreme being, drawing on poetic imagery to enhance the scene's vibrancy.
Indice
Il dubbio di Dante
Nel Primo Mobile appare a Dante un punto luminosissimo (Dio), intorno al quale si . muovono nove cerchi concentrici (i cori angelici). Il Poeta osserva che questi cerchi, dal primo al nono, aumentano in grandezza e diminuiscono in splendore. Tale fatto suscita in lui un grave dubbio: nell’ordine cosmico i cieli, quanto più si allontanano dalla terra (centro dell’universo), tanto più appaiono vasti, mentre, nei cerchi angelici, quello più vicino a Dio è il più piccolo. Poiché dalle intelligenze angeliche dipende e viene regolato il moto dei cieli, come può essere spiegata questa contraddizione? Nelle sfere fisiche - chiarisce Beatrice - la grandezza è in proporzione della potenza o "virtù" che viene infusa in esse dalle intelligenze angeliche, per essere poi trasmessa al mondo sottostante perciò il cielo più grande è quello più dotato dí virtù e, quindi, più potenzíalmente capace di influssi salutari. Occorrerà, dunque, che i cieli più vasti siano governati dalle intelligenze angeliche più dotate di virtute. Per questo al cielo più grande, il Primo Mobile, corrisponderà il cerchio angelico più vicino a Dio: quello dei Serafini, il più piccolo di tutti. Poi Beatrice enumera a Dante tutti i nove cori angelici, raccogliendoli in tre gerarchie, ciascuna delle quali costituita da tre cori: Serafini - Cherubini’ - Troni, Dominazioni - Virtù - Potestà, Principati - Arcangeli - Angeli.
Negli ultimi versi del canto Dante dichiara di accogliere, riguardo alle intelligenze celesti, la disposizione fissata da Dionigi l’Areopagita, respingendo quella di Gregorio Magno.
La critica di De Sanctis
La posizione critica del De Sanctis di fronte alla terza cantica può essere cosi riassunta: tema del Paradiso è il divino, il puro spirito, qualcosa che è al di la dell’immaginazione della poesia e dell’uomo; Dante, per rappresentarlo, ricorre ad una forma " musicale ", ad una visione, cioè, che presenta fantasmi evanescenti anziché corpi distinti.  Tuttavia questa forma, per quanto assottigliata, e ancora "soverchia", presenta un "troppo vivo colore per rispetto al puro divino"; può essere adatta per la rappresentazione delle anime beate, dove c’è ancora qualche traccia dell’umano, ma "falsificherebbe il divino la cui essenza è di non aver forma e di sottrarsi all’immaginazione". Perciò quando Dante si accosta al divino, deve attingerlo "non con la forma ma con la negazione della forma. Le estreme tenebre e l’estrema luce conseguono entrambe lo stesso effetto rubandoci la vista degli oggetti". Scopo del Poeta non è quello di offrirci la "visione" del paradiso, ma il "sentimento" di essa; tuttavia "questo sentimento celeste si rivela in alcuni pochi tratti, ed in modo troppo indeterminato", per cui solo l’intervento del terreno può conferirgli "maggior varietà e colore". Tuttavia il De Sanctis ha coperto troppo in fretta con la luce tutto il paradiso dantesco ("nel paradiso e il soverchio della luce, che toglie a Dante la visione") e non ha considerato il presupposto fondamentale della poetica della terza cantica: la caratteristica del sentimento religioso del Medioevo - di cui Dante offre una delle più alte testimonianze - consiste nella volontà, tenacemente, perseguita, di rappresentare il mondo sovrannaturale nel modo più concreto e dettagliato possibile. Nella spiritualità moderna non sì pensa a descrivere Dio, a precisare quanti sono gli angeli o in che posizione essi si trovano rispetto a Dio, ne si tenta di definire le parti in cui è diviso il paradiso e di distinguerne i differenti gradi di luce, di verità, di beatitudine. Anche per lo spirito cristiano piú profondo, oggi, Dio è nell’osservanza dell’insegnamento della Chiesa, nell’ansia e nel fervore dell’anima che si eleva verso di Lui, ma non è in nessuna figurazione concreta. Tuttavia questa diversa - ma non contrastante - posizione di fronte al sovrannaturale, non ci può impedire una lettura obiettiva del canto XXVIII, dove, per la prima volta, Dante tenta una rappresentazione diretta di Dio (un punto... che raggiava lume acuto sì, che ‘l viso ch’elli affoca chiuder conviensi per lo forte acume) e delle gerarchie angeliche.
Tuttavia questa forma, per quanto assottigliata, e ancora "soverchia", presenta un "troppo vivo colore per rispetto al puro divino"; può essere adatta per la rappresentazione delle anime beate, dove c’è ancora qualche traccia dell’umano, ma "falsificherebbe il divino la cui essenza è di non aver forma e di sottrarsi all’immaginazione". Perciò quando Dante si accosta al divino, deve attingerlo "non con la forma ma con la negazione della forma. Le estreme tenebre e l’estrema luce conseguono entrambe lo stesso effetto rubandoci la vista degli oggetti". Scopo del Poeta non è quello di offrirci la "visione" del paradiso, ma il "sentimento" di essa; tuttavia "questo sentimento celeste si rivela in alcuni pochi tratti, ed in modo troppo indeterminato", per cui solo l’intervento del terreno può conferirgli "maggior varietà e colore". Tuttavia il De Sanctis ha coperto troppo in fretta con la luce tutto il paradiso dantesco ("nel paradiso e il soverchio della luce, che toglie a Dante la visione") e non ha considerato il presupposto fondamentale della poetica della terza cantica: la caratteristica del sentimento religioso del Medioevo - di cui Dante offre una delle più alte testimonianze - consiste nella volontà, tenacemente, perseguita, di rappresentare il mondo sovrannaturale nel modo più concreto e dettagliato possibile. Nella spiritualità moderna non sì pensa a descrivere Dio, a precisare quanti sono gli angeli o in che posizione essi si trovano rispetto a Dio, ne si tenta di definire le parti in cui è diviso il paradiso e di distinguerne i differenti gradi di luce, di verità, di beatitudine. Anche per lo spirito cristiano piú profondo, oggi, Dio è nell’osservanza dell’insegnamento della Chiesa, nell’ansia e nel fervore dell’anima che si eleva verso di Lui, ma non è in nessuna figurazione concreta. Tuttavia questa diversa - ma non contrastante - posizione di fronte al sovrannaturale, non ci può impedire una lettura obiettiva del canto XXVIII, dove, per la prima volta, Dante tenta una rappresentazione diretta di Dio (un punto... che raggiava lume acuto sì, che ‘l viso ch’elli affoca chiuder conviensi per lo forte acume) e delle gerarchie angeliche.
La rappresentazione del divino
Occorre, a nostro parere, insistere sul concetto di " rappresentazione ", sullo sforzo e la tesa volontà, da parte del Poeta, di tradurre visivamente il mondo dell’astrazione pura. Questo non significa un ritorno ai principii della critica romantica ( ricerca - fine a se stessa - dell’immagine e del concreto), ma un modo di lettura più obiettivo, più vicino, cioè, agli intenti " rappresentativi " del Poeta. Poiché Dante non vuole soltanto rappresentare il suo sentimento del paradiso (la percezione della gloria del Creatore e delle sue creature in un’attonita luce d’eterno), ma vuole anche descrivere, nel canto XXVIII e nel XXXIII, Dio. Possiamo forse affermare che nel XXVIII non esiste poesia perché Dante si accosta a realtà - Dio e gli angeli - che, per loro natura, si sottraggono a qualsiasi concreto rilievo? Ma, di questo passo, anche le immaginifiche creazioni dell’Ariosto dovrebbero essere sottoposte alla censura della critica.
L'arte della descrizione dantesca
Il canto della cosmologia dantesca deve essere letto tenendo ben presenti l’inesausto descrivere del Poeta (ciò che egli cerca in ogni momento è la possibilità di trovare parole e immagini adeguate a ciò che ha visto e si e impresso nella sua mente), l’ardore religioso che anima e dirige questo sforzo, la sicurezza del dialogo teologico che sorregge entrambi.
All’inizio del canto, quando appare il punto luminoso, di Dio, e nella descrizione, fatta da Beatrice, dei cori angelici, ci troviamo di fronte a un’esperienza mistica, ma la posizione del Poeta "rimane quella di chi ritrae una realtà e una vicenda autonome" (Montano), non venendo mai meno "alla obiettività della sua rappresentazione e alla fermezza del suo distacco dalla materia trattata". Non c’e dunque "impassibilità", come vorrebbe il Vandelli (secondo il quale, di fronte alla mirabile teofania del canto XXVIII, non c’e, nel Poeta, "una sola parola che ci attesti o ci faccia intravedere la commozione del suo spirito"), né, tanto meno, un tono astratto e rigidamente ragionativo, bensì la capacita, che e quella dei grandi poeti, di rievocare un’esperienza personale e un’emozione profonda in termini di logica chiarezza e in esiti espressivi di pregnante significato.
La visione angelica
A proposito della realizzazione formale della visione che ha per suo centro il moto vertiginoso degli angeli (nel quale si riflette tutta la dinamica dei cieli) e la sublime staticità dell’Ente supremo, è sufficiente un esempio molto significativo. Quando Dante presenta la seconda gerarchia angelica che gira intorno al punto luminoso (versi 115-117), ricorre ad un’immagine (l’altro ternaro, che così germoglia in questa primavera sempiterna che notturno Ariete non dispoglia) che e probabilmente imposta o condizionata da una suggestiva attrazione di rime. Infatti, dalla rima (rara e difficile) voglia del verso 113 scaturisce la comparazione del ternaro degli angeli con un albero che germoglia in mezzo ad un’eterna primavera. L’immagine, come osserva il Parodi, riesce alquanto inattesa, e non sgorga necessariamente dal contesto né illustra o continua il pensiero fondamentale, ma si svolge, per così dire, a fianco di esso, lumeggiando particolari ai quali l’attenzione non si sarebbe rivolta. Tuttavia "non è ridondante, poiché ad un tratto codesti particolari si confondono coll’insieme, facendo lampeggiare d’un riso primaverile tutta la scena; e il terzo verso che notturno Ariete non dispoglia, uno dei piú bei versi di Dante, compie in noi la visione, coll’evocazione magica della notte e il confronto della primavera terrena".
Domande da interrogazione
- Qual è il dubbio che assale Dante nel Primo Mobile?
- Come De Sanctis critica la rappresentazione del divino nel Paradiso di Dante?
- Qual è l'approccio di Dante nella rappresentazione del divino e delle gerarchie angeliche?
- Qual è l'arte della descrizione dantesca nel canto della cosmologia?
- Come viene realizzata la visione angelica nel canto XXVIII?
Dante si interroga sul perché, nei cerchi angelici, quello più vicino a Dio sia il più piccolo, mentre nei cieli fisici, quelli più lontani dalla terra sono più vasti. Beatrice spiega che la grandezza dei cieli è proporzionale alla virtù infusa dalle intelligenze angeliche.
De Sanctis sostiene che il tema del divino è al di là dell'immaginazione poetica e che Dante, per rappresentarlo, utilizza una forma musicale che rischia di falsificare il divino, poiché la sua essenza è di non avere forma.
Dante cerca di tradurre visivamente il mondo dell'astrazione pura, non solo rappresentando il sentimento del paradiso, ma anche descrivendo Dio e le gerarchie angeliche nei canti XXVIII e XXXIII.
L'arte della descrizione dantesca si basa sull'inesausto sforzo di trovare parole e immagini adeguate, animato da un ardore religioso e sostenuto da un dialogo teologico sicuro, mantenendo obiettività e distacco dalla materia trattata.
La visione angelica è centrata sul moto vertiginoso degli angeli e la staticità dell'Ente supremo, con immagini che, pur non necessarie al contesto, arricchiscono la scena con particolari che si fondono con l'insieme, evocando una visione magica.

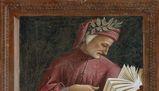








 Accedi a tutti gli appunti
Accedi a tutti gli appunti
 Tutor AI: studia meglio e in meno tempo
Tutor AI: studia meglio e in meno tempo